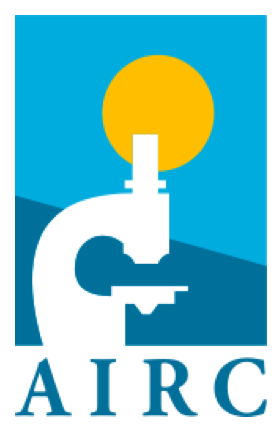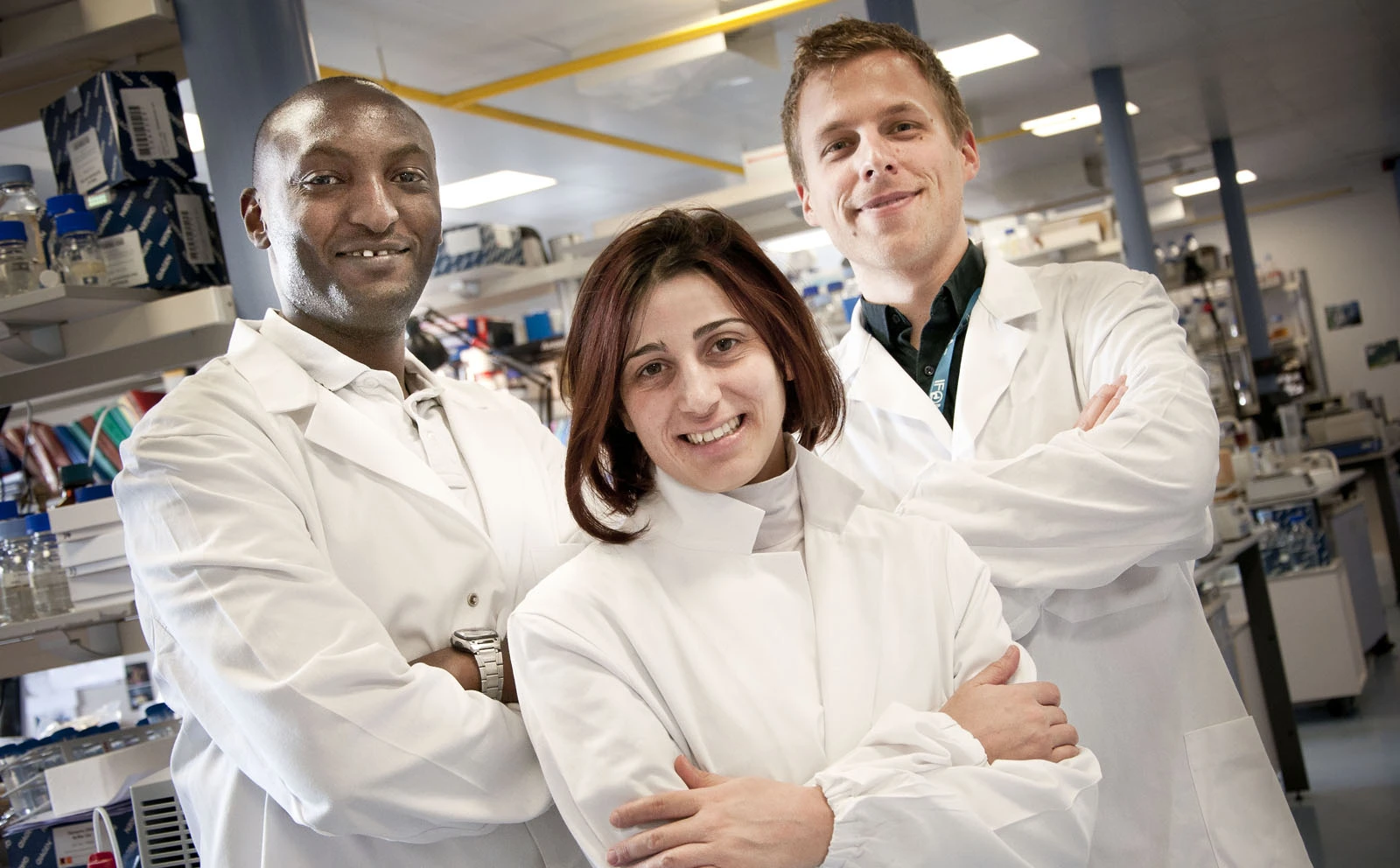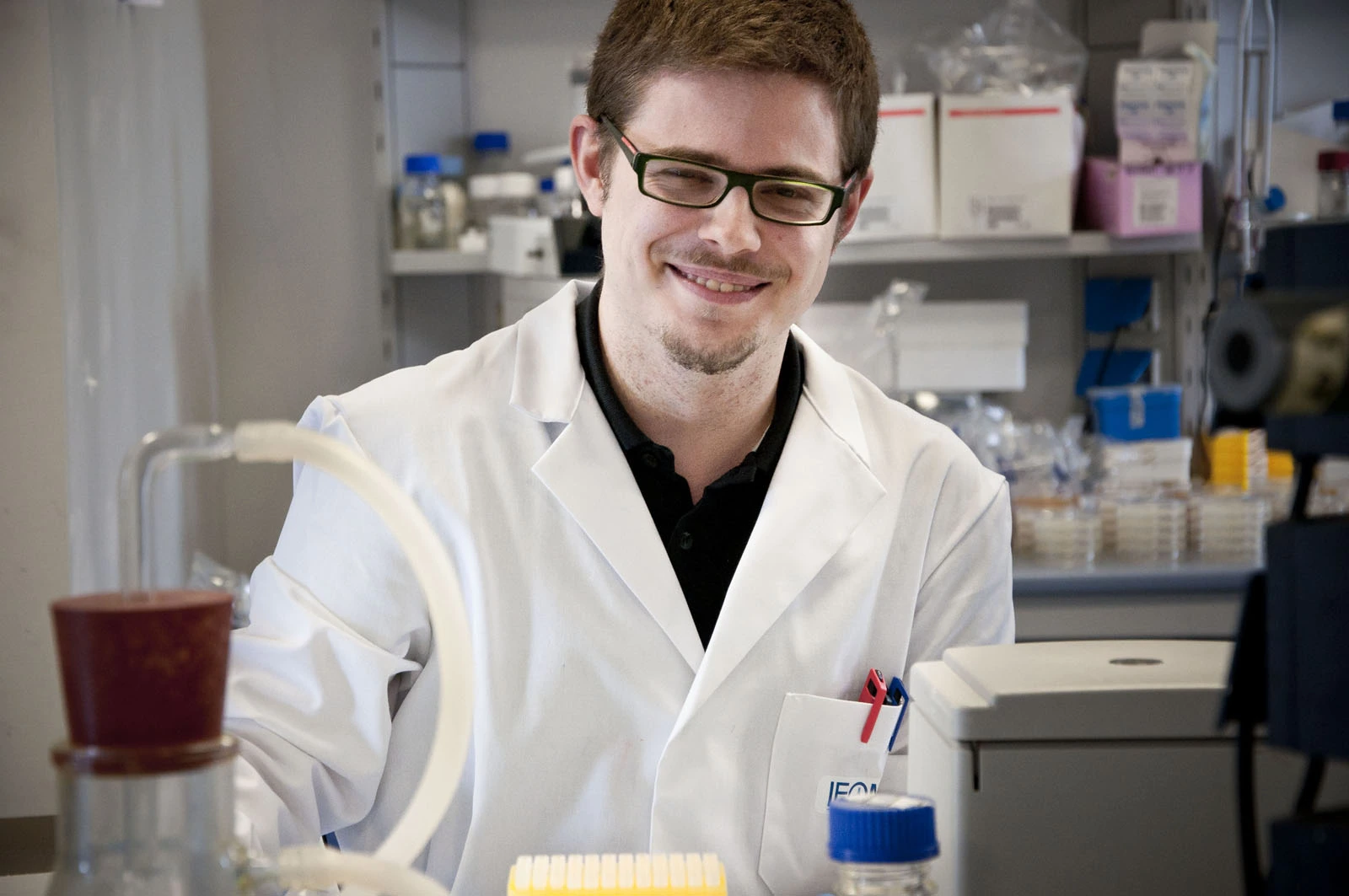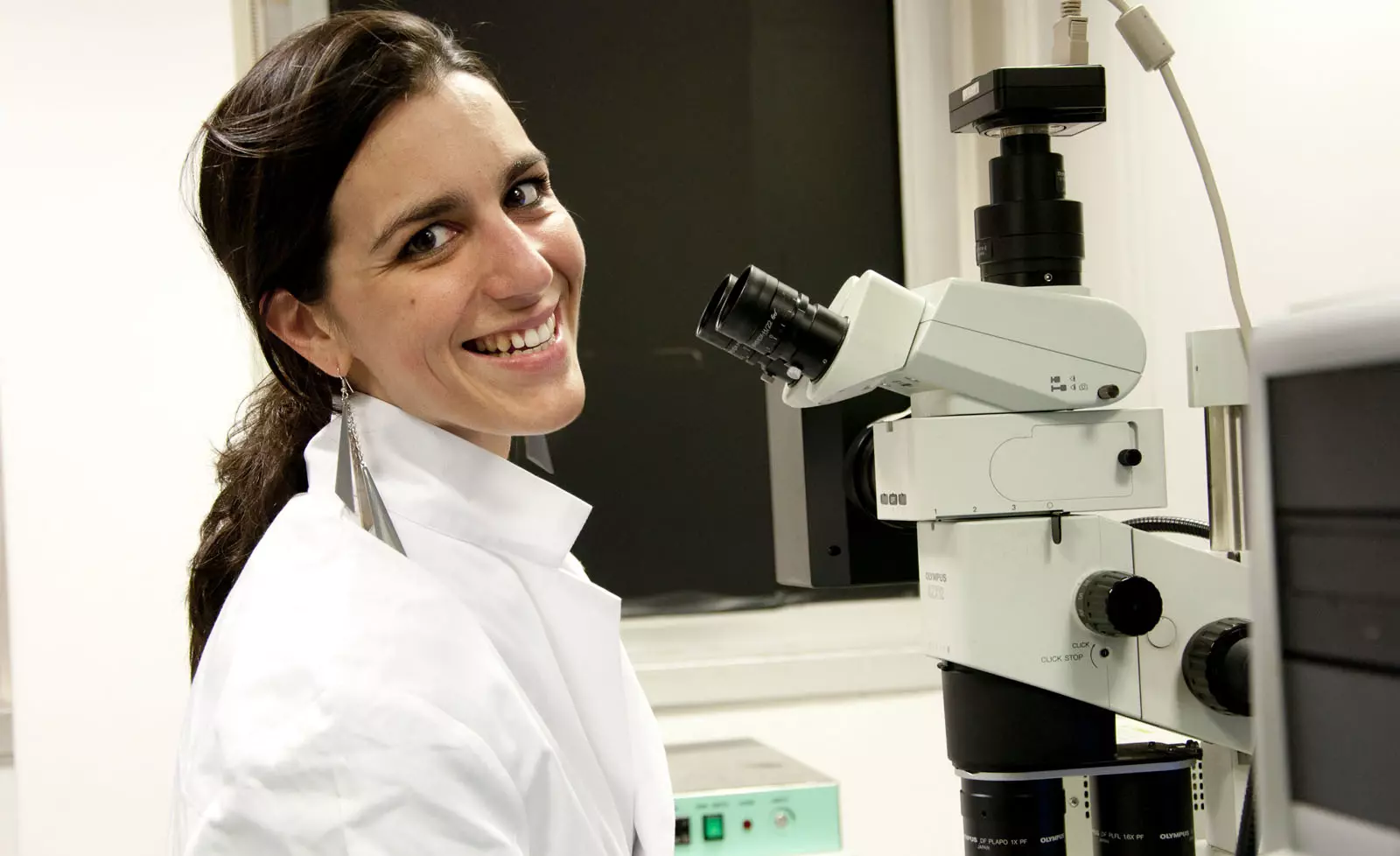Epigenetica e immunoterapia unite nella sfida alle metastasi
Il tumore è in genere dovuto a un’alterazione nei geni. Non sempre, però, si tratta di geni mutati nella loro struttura, ovvero nella sequenza del DNA delle cellule tumorali. In alcuni casi si hanno modificazioni epigenetiche: si tratta di cambiamenti più superficiali, dovuti all’aggiunta o alla rimozione di specifiche molecole che, legandosi al DNA, ne modificano l’espressione contribuendo allo sviluppo del tumore. Negli anni è emersa sempre più l’importanza del ruolo delle modificazioni epigenetiche nella comprensione dei meccanismi della trasformazione neoplastica e della progressione tumorale. Proprio sull’epigenetica si concentra l’attenzione dei ricercatori guidati da Michele Maio, dell’Università di Siena e dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, che nel loro programma speciale AIRC “5 per mille” si propongono di valutare come queste modifiche influenzino la formazione di metastasi e alterino il microambiente che le circonda, nonché la risposta all’immunoterapia. “L’idea generale, che portiamo avanti grazie al sostegno di AIRC, è studiare le modificazioni epigenetiche e identificare quelle tipiche delle diverse fasi della progressione della malattia, fino ad arrivare alla fase di diffusione attraverso le metastasi. Questo potrà aiutarci a capire meglio perché in alcuni casi si crea un ambiente ostile all’immunoterapia, la strategia terapeutica che stimola il nostro sistema immunitario contro il cancro” spiega Maio. La prima parte del programma si sviluppa nel melanoma, sui quali gli scienziati lavorano già da diverso tempo e la ricerca è più avanzata, con alcuni studi anche in clinica. Successivamente le conoscenze acquisite in questa patologia saranno trasferite al mesotelioma e al glioblastoma, tumori nei quali è indispensabile identificare nuove e più efficaci strategie terapeutiche, con particolare riguardo all’immunoterapia.
Gli obiettivi
Le modifiche epigenetiche possono fornire al tumore un’importante via di fuga, rendendolo invisibile al sistema immunitario e riducendo quindi l’efficacia dell’immunoterapia. In questo processo, numerose cellule presenti nel microambiente in cui il tumore prolifera hanno un ruolo di rilievo nel favorire il progresso tumorale. Uno degli obiettivi principali del programma coordinato da Michele Maio è caratterizzare i meccanismi epigenetici che regolano la relazione tra tumore, microambiente tumorale e cellule del sistema immunitario. “Anche da questa relazione dipende la capacità della malattia di progredire, dare metastasi ed eventualmente di diventare resistente all’immunoterapia, in particolare ai cosiddetti farmaci inibitori dei checkpoint immunitari” precisa Maio. Gli altri obiettivi della ricerca sono una conseguenza diretta del primo: si tratta di comprendere il ruolo delle diverse alterazioni osservate nel tumore a livello epigenetico e coinvolte nella resistenza all’immunoterapia, e di sviluppare innovative strategie di cura che coinvolgano sia farmaci epigenetici sia farmaci immunoterapici come gli inibitori dei checkpoint.
Il percorso
- Analisi integrate. Nel programma è prevista una prima fase basata su analisi multi-omiche integrate di tessuti di melanoma, ma anche di mesotelioma e glioblastoma. Queste coinvolgono l’epigenoma (l’insieme delle caratteristiche epigenetiche del DNA), il trascrittoma (l’insieme dei geni che vengono espressi sotto forma di RNA messaggero) e il mutatoma (l’insieme delle mutazioni che possono verificarsi nel DNA).
- Nuove correlazioni e nuovi bersagli. I ricercatori guidati da Maio stanno mettendo in relazione le informazioni ottenute dalle analisi multi-omiche integrate sulla progressione della malattia (inclusa la diffusione sotto forma di metastasi), il contesto immunitario nel quale il tumore si muove e prolifera, e la resistenza alle immunoterapie. Cercheranno inoltre di identificare nuovi processi o molecole capaci di favorire la formazione delle metastasi, anche a livello cerebrale, e possibili nuovi bersagli di farmaci specifici.
- Rimodulare il dialogo. Il programma AIRC “5 per mille” guidato da Maio e i suoi colleghi prevede anche di studiare i meccanismi dei possibili farmaci epigenetici in animali di laboratorio, nei quali analizzare anche il continuo dialogo fra sistema immunitario e tumore. “Dobbiamo comprendere come questo dialogo si modifica nel tempo anche in base alla progressione della malattia” spiega Maio, ricordando il grande vantaggio di poter partire per le analisi da campioni tumorali prelevati da pazienti in diversi momenti della malattia.
- Dal laboratorio ai pazienti. Le informazioni emerse dal programma costituiranno la base scientifica per ideare e attivare studi clinici altamente innovativi, tesi a valutare l’efficacia di terapie combinate di farmaci epigenetici e immunoterapici inibitori dei checkpoint in pazienti con melanoma metastatico. Successivamente questi studi clinici verranno attivati anche per i pazienti con mesotelioma e glioblastoma.
- L’unione fa la forza. Un programma vasto e complesso come quello pensato dai ricercatori guidati da Michele Maio richiede un grande sforzo non solo economico, ma anche in termini di tecnologia e competenze. “Grazie ad AIRC siamo riusciti a creare una cordata di eccellenti ricercatori con competenze diverse e complementari, in grado di lavorare in modo assolutamente integrato verso un obiettivo comune, portando un grande contributo alla ricerca” spiega il coordinatore.
Perché è importante
L’immunoterapia rappresenta oggi una strategia terapeutica sempre più utilizzata nella cura dei tumori, ma nonostante i grandi successi già ottenuti, restano ancora molte domande aperte per migliorarne l’efficacia. Una di queste riguarda il fatto che non tutti i tumori rispondono bene ai farmaci immunoterapici, mentre alcuni possono smettere di rispondere con il passare del tempo, e le ragioni di questi comportamenti non sono ancora del tutto note. Grazie al programma sostenuto da AIRC si potranno comprendere meglio alcuni meccanismi che portano alla resistenza alla immunoterapia ed allo sviluppo di metastasi. Inoltre, si potranno sviluppare trattamenti mirati a migliorare la risposta all’immunoterapia in base alle caratteristiche biologiche, immunologiche e molecolari del tumore di ciascun paziente. Un beneficio pratico importante che permetterà di gestire meglio e in modo più preciso e mirato la terapia antitumorale nei pazienti inizialmente nella fase avanzata della malattia e, prospetticamente, anche nelle fasi più iniziali.
A che punto siamo
Aprile 2025. Gli studi iniziali hanno posto le basi per comprendere meglio quali modificazioni epigenetiche possono occorrere nelle cellule tumorali. Inoltre, si è iniziato a comprendere come tali modificazioni influiscano sulla risposta clinica all’immunoterapia. Tutto questo è stato possibile anche grazie ad analisi computazionali multi-omiche integrate che permettono di studiare ciò che accade a livello epigenetico nelle cellule tumorali, e le conseguenti interazioni tra tali cellule e le cellule (immunitarie e non) che popolano il microambiente tumorale. Inoltre, le analisi consentono anche di predire quali potrebbero essere gli esiti clinici di alcuni interventi terapeutici.
I ricercatori coordinati da Maio hanno poi raggiunto un altro importante risultato: hanno identificato il farmaco epigenetico più adatto agli studi clinici previsti per raggiungere gli obiettivi del programma. “Abbiamo cercato il farmaco più efficace a indurre le modificazioni del microambiente tumorale, del tumore stesso e delle cellule circolanti del sistema immunitario, da utilizzare negli studi clinici di immunoterapia previsti dal programma” spiega Maio. Una prima selezione degli effetti di diverse famiglie di farmaci epigenetici è avvenuta in cellule tumorali in coltura. Quindi, i ricercatori sono passati alla verifica in animali di laboratorio: una conferma necessaria prima di passare agli studi clinici nei pazienti oncologici. “Ora sappiamo che i farmaci che rimuovono gruppi metili dal DNA (ipometilanti) sono maggiormente in grado, in animali di laboratorio, di rendere il tumore ‘caldo’, ovvero, in gergo, infiltrato efficacemente da cellule del sistema immunitario che sono in grado di distruggere le cellule tumorali” afferma Maio.
Sempre attraverso studi in animali di laboratorio, il gruppo ha anche potuto comprendere che i farmaci ipometilanti il DNA possono rendere più efficiente il dialogo fra il tumore e l’ambiente che lo circonda, attivando una maggiore risposta del sistema immunitario contro la malattia. Questi risultati sono stati confermati anche dai dati generati nello studio clinico NIBIT-M4, la prima sperimentazione al mondo in cui pazienti affetti da melanoma metastatico sono stati trattati con la combinazione di un farmaco ipometilante il DNA e un agente immunoterapico, inibitore del checkpoint immunitario CTLA-4. In questo studio i ricercatori hanno dimostrato la sicurezza e la tollerabilità della somministrazione combinata dei due farmaci. Inoltre, hanno osservato che a seguito della terapia erano maggiormente espressi i geni fondamentali per il riconoscimento del tumore da parte del sistema immunitario dei pazienti.
Impiegando un’analisi multi-omica integrata di campioni di tessuti tumorali ottenuti dai pazienti all’inizio e durante la terapia, è stato possibile identificare e quantificare gli elementi che interagiscono tra il sistema immunitario e le cellule tumorali. In base ai dati raccolti con queste analisi, i ricercatori sono riusciti a suddividere i pazienti trattati nello studio in 4 differenti categorie e a prevedere con maggiore precisione la risposta clinica e la sopravvivenza a 5 anni dall’inizio del trattamento.
Grazie alle osservazioni ottenute in questa fase iniziale del programma, ha preso il via lo studio clinico multicentrico NIBIT-ML1, a cui partecipano attivamente oltre 20 centri oncologici italiani. I pazienti coinvolti hanno un melanoma avanzato per il quale la precedente immunoterapia con gli inibitori del checkpoint PD-1 non è stata efficace. Si tratta di pazienti che mostrano sia una resistenza primaria, ovvero che non rispondono affatto ai trattamenti, sia una resistenza secondaria, in cui cioè l’immunoterapia ha funzionato in un primo momento, per poi non avere più effetto. I pazienti con tumori resistenti sono divisi in due gruppi, uno trattato con una combinazione di due inibitori dei checkpoint (anti-PD1 e anti-CTLA4) e l’altro trattato con la stessa combinazione con l’aggiunta del farmaco ipometilante il DNA, che è stato identificato come il più promettente nelle fasi iniziali del programma. “Oltre a cercare di capire se possiamo superare la resistenza con la combinazione di due inibitori dei checkpoint, vogliamo comprendere se con le modificazioni indotte dal farmaco epigenetico riusciamo a ottenere ulteriori miglioramenti dell’efficacia dell’immunoterapia” chiarisce lo specialista.
Dopo un’indispensabile prima fase condotta in 6 pazienti, in cui è stata dimostrata la sicurezza e la tollerabilità della tripla combinazione terapeutica, è prevista l’aggiunta del farmaco ipometilante il DNA alla combinazione dei due inibitori dei checkpoint immunitari. A oggi in questo studio, anch’esso unico al mondo, sono stati arruolati tutti i 36 pazienti previsti nella fase randomizzata dello studio clinico. I risultati clinici ottenuti sono in corso di analisi, e sono stati selezionati per una presentazione orale al prossimo Congresso internazionale della American Society of Clinical Oncology che si terrà a giugno 2025 a Chicago. Inoltre, i ricercatori stanno attivamente analizzando i campioni biologici raccolti dai pazienti arruolati nello studio NIBIT-ML1, per confermare i potenziali biomarcatori di risposta al trattamento precedentemente identificati e studiare gli effetti indotti dall’aggiunta del farmaco epigenetico al trattamento immunoterapico.
Per analizzare al meglio l’enorme mole di dati già disponibili attraverso le analisi multi-omiche sviluppate nelle fasi iniziali del programma, e quelli ulteriori emersi dagli studi clinici, si è aggregata al gruppo originale di ricercatori un’unità operativa di biologia computazionale. Raccontando di questo importante inserimento, il coordinatore ha ricordato l’utile flessibilità alla base dei programmi AIRC “5 per mille”, che permette di rimodulare il consorzio dei ricercatori che ne fanno parte sulla base dei risultati e delle necessità emergenti dagli studi svolti.
Ma lo studio non si è fermato al melanoma. L’idea è di partire dalle scoperte più salienti ottenute in questo tipo di tumore, e che sembrano essere interessanti dal punto di vista della modificazione e della immuno-modulazione epigenetica, per valutarle anche nel glioblastoma e mesotelioma sia in cellule in coltura sia in animali di laboratorio.
“Recentemente abbiamo dimostrato che le alterazioni epigenetiche possono essere anche responsabili della minore risposta all’immunoterapia dei tumori cerebrali primitivi, come il glioblastoma multiforme, rispetto ai tumori cerebrali secondari, come le metastasi cerebrali da melanoma” spiega Maio. “Cellule in coltura di glioblastoma derivate da espianti chirurgici di pazienti affetti da questo tumore estremamente aggressivo e trattate con farmaci ipometilanti il DNA modificano infatti il proprio profilo immunologico, diventando più simili a quelle derivate da metastasi cerebrali da melanoma. Quindi, divengono potenzialmente più sensibili al trattamento con farmaci diretti contro i checkpoint immunitari, come abbiamo dimostrato nello studio NIBIT-M2, sempre nell’ambito del nostro programma ‘5 per mille’”.
Sul mesotelioma, Maio e i suoi collaboratori lavorano da oltre un decennio, come documentano i risultati già pubblicati, e in particolare la dimostrazione della maggiore efficacia della combinazione anti-PD-1 e anti-CTLA4 in pazienti con mesotelioma pleurico (studiata per la prima volta proprio in questo contesto) rispetto ai due farmaci usati singolarmente. Nell’ambito del consorzio, i ricercatori hanno infatti dimostrato che circa la metà dei pazienti diventati resistenti alla combinazione terapeutica risponde se viene sottoposto nuovamente al trattamento con gli stessi farmaci (una strategia detta rechallenge). Inoltre, i pazienti con un numero più elevato di mutazioni (quello che i tecnici chiamano tumour molecular burden, abbreviato in TMB) ottengono risultati migliori in termini sia di risposta clinica sia di sopravvivenza.
“Le ricerche sul mesotelioma che stiamo svolgendo sono effettuate anche attraverso studi iniziali in cellule in coltura che abbiamo pubblicato recentemente. L’obiettivo è caratterizzare i meccanismi epigenetici di resistenza delle cellule tumorali all’immunoterapia. Inoltre, puntiamo a studiare il potenziale di farmaci epigenetici nello sviluppo di nuove e, auspicabilmente, più efficaci strategie immunoterapiche di combinazione. Lo scopo è migliorare la risposta clinica dei pazienti, nonché selezionare coloro che ne potrebbero essere i migliori candidati. A tale proposito, recentemente nel gruppo originale di ricercatori è stata inserita una nuova unità esperta nella gestione clinica dei pazienti affetti da mesotelioma, a supporto delle attività cliniche previste nel programma” conclude Maio.
Un lavoro di squadra
Per poter generare in modo tempestivo risultati scientifici importanti, che possano essere trasferiti altrettanto rapidamente all’applicazione clinica, il programma di ricerca sostenuto da Fondazione AIRC necessitava di mettere insieme sin dall’inizio una grande squadra di ricercatori, tra i migliori in Italia e a livello internazionale, che potessero fornire tutte le differenti competenze indispensabili ad affrontare le ricerche da diverse angolazioni e in strettissima integrazione. Così, inizialmente il coordinatore del programma, che in inglese viene chiamato Principal Investigator (PI), ha identificato 5 group leader, a cui se sono aggiunti altri 3 nel corso della ricerca. Insieme ai loro gruppi di ricerca e a ulteriori unità da loro identificate come utili alla progettualità complessiva, i Group leader hanno apportato tutte le competenze di altissimo livello necessarie. In particolare:
- Andrea Anichini (Unità di immunobiologia dei tumori umani, Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano), è co-PI del programma e porta la propria esperienza nell’ambito dell’immunobiologia e immunoterapia dei tumori umani;
- Michele Ceccarelli (Cattedra di sistemi di elaborazione delle informazioni presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” e laboratorio di bioinformatica di Biogem) è un biologo computazionale che contribuisce all’analisi integrata dell’enorme mole di dati generata in laboratorio e in clinica dal consorzio;
- Daniela Massi (Cattedra di anatomia patologica, Università degli studi di Firenze) contribuisce con la sua esperienza di anatomopatologa a tutte le fasi del programma che prevedono l’analisi multi-parametrica di tessuti tumorali necessari alla ricerca;
- Giuseppe Palmieri (Cattedra di oncologia medica e molecolare, Università degli studi di Sassari e IRGB-CNR di Sassari) porta all’interno del programma la sua esperienza nella genetica dei tumori umani;
- Ulrich Pfeffer (Unità di epigenetica dei tumori, IRCCS Ospedale policlinico San Martino di Genova) offre la sua competenza di biologo cellulare e molecolare in modelli tumorali umani e murini;
- Luana Calabrò (cattedra di oncologia Medica, Università degli Studi di Ferrara) contribuisce con le sue competenze nell’ambito dell’immunobiologia e dell’immunoterapia del mesotelioma pleurico;
- Beatrice Bodega (Istituto nazionale di genetica molecolare presso l’Università degli studi di Milano) offre le sue competenze sul ruolo dell’epigenetica nel regolare la funzione dei linfociti T effettori.
Il lavoro continuo di questa squadra, che prevede anche riunioni settimanali per la condivisione dei rispettivi risultati ottenuti e che coinvolge decine di ricercatori di laboratorio e clinici, continua a generare dati importanti. Parte di tali risultati è già stata trasferita in clinica, in pazienti oncologici affetti da melanoma cutaneo e da mesotelioma, come auspicabilmente avverrà a breve anche per pazienti affetti da glioblastoma multiforme, così come previsto dal programma.
Il programma di ricerca è un’importante opportunità di collaborazione e di crescita professionale e personale per tutta la squadra e dei tanti giovani ricercatori che ne fanno parte.