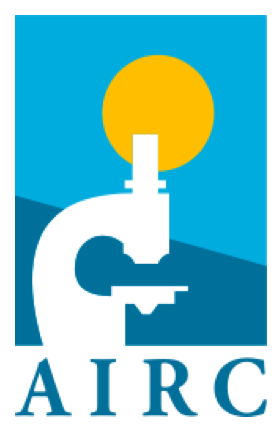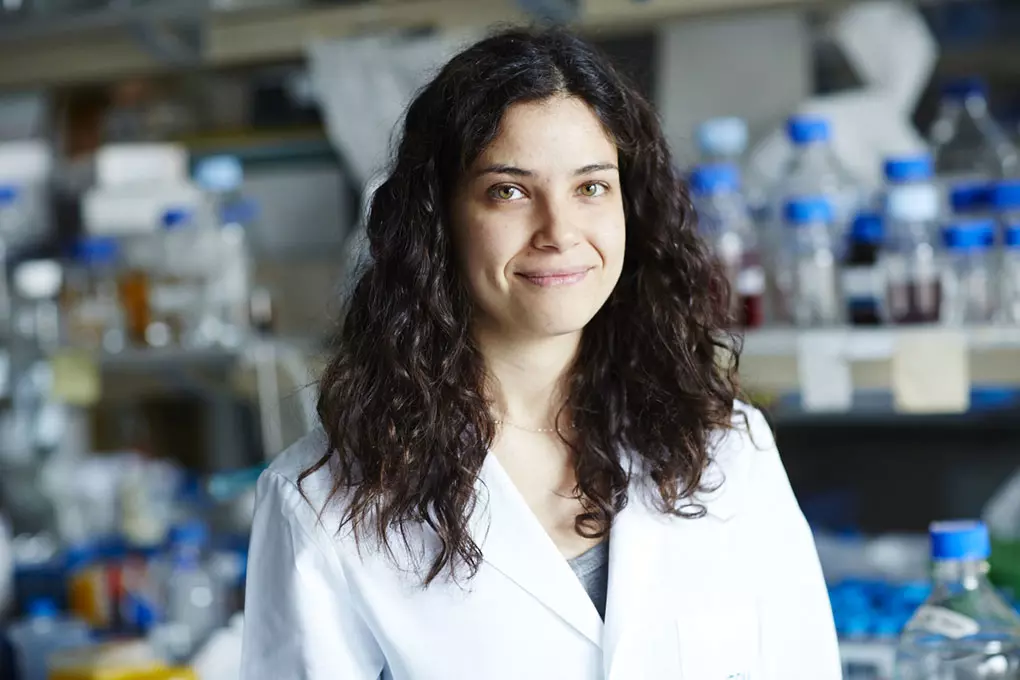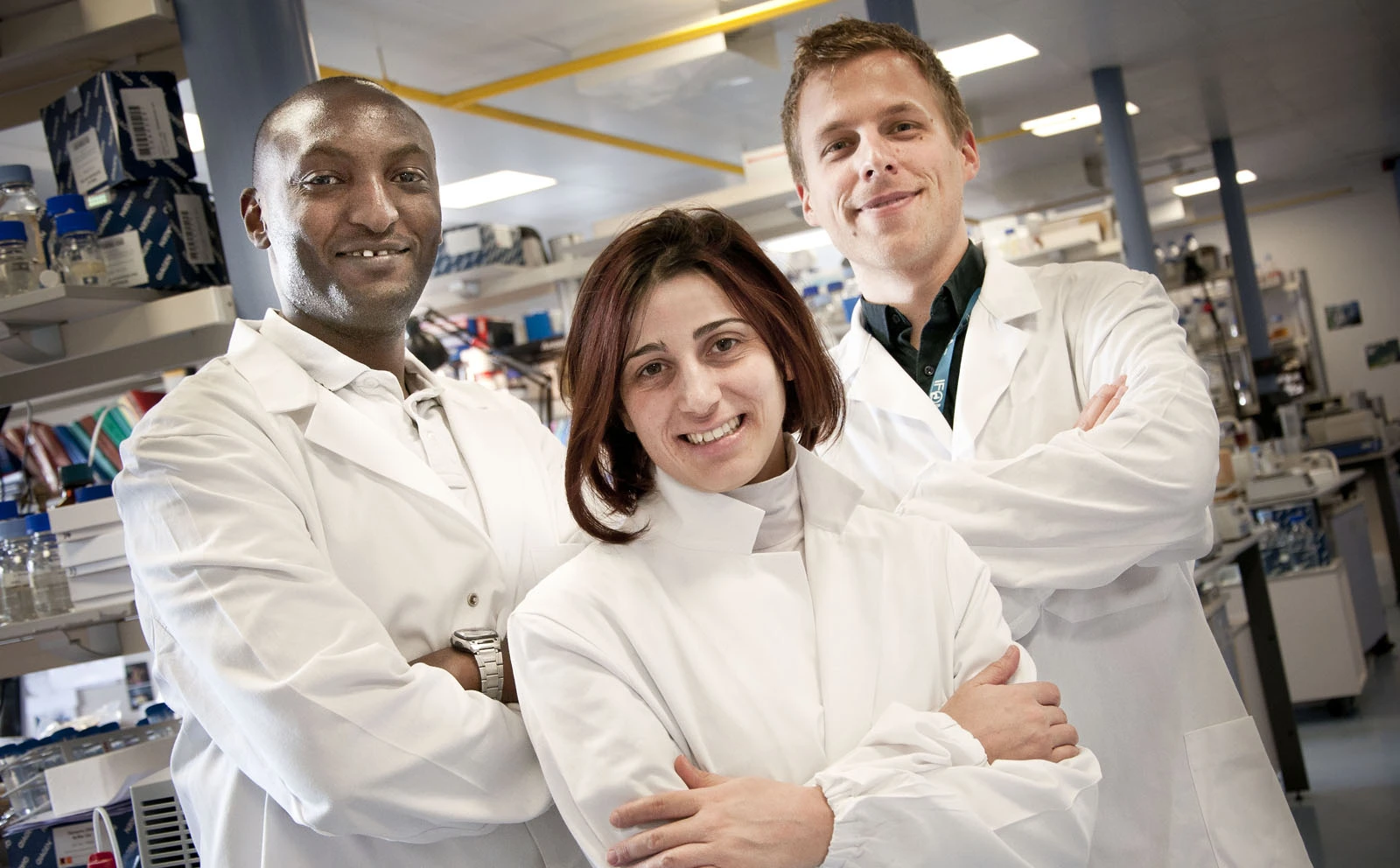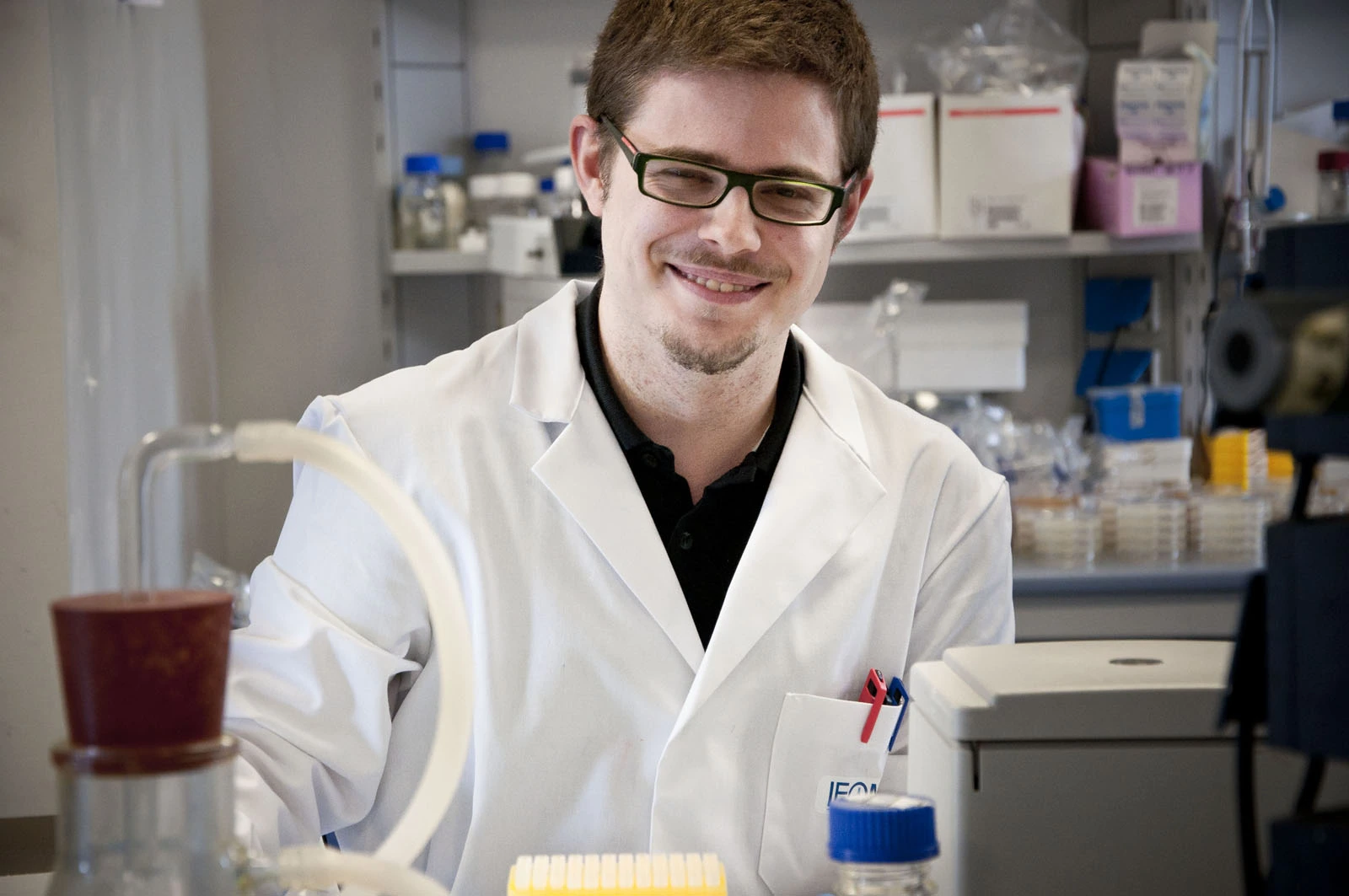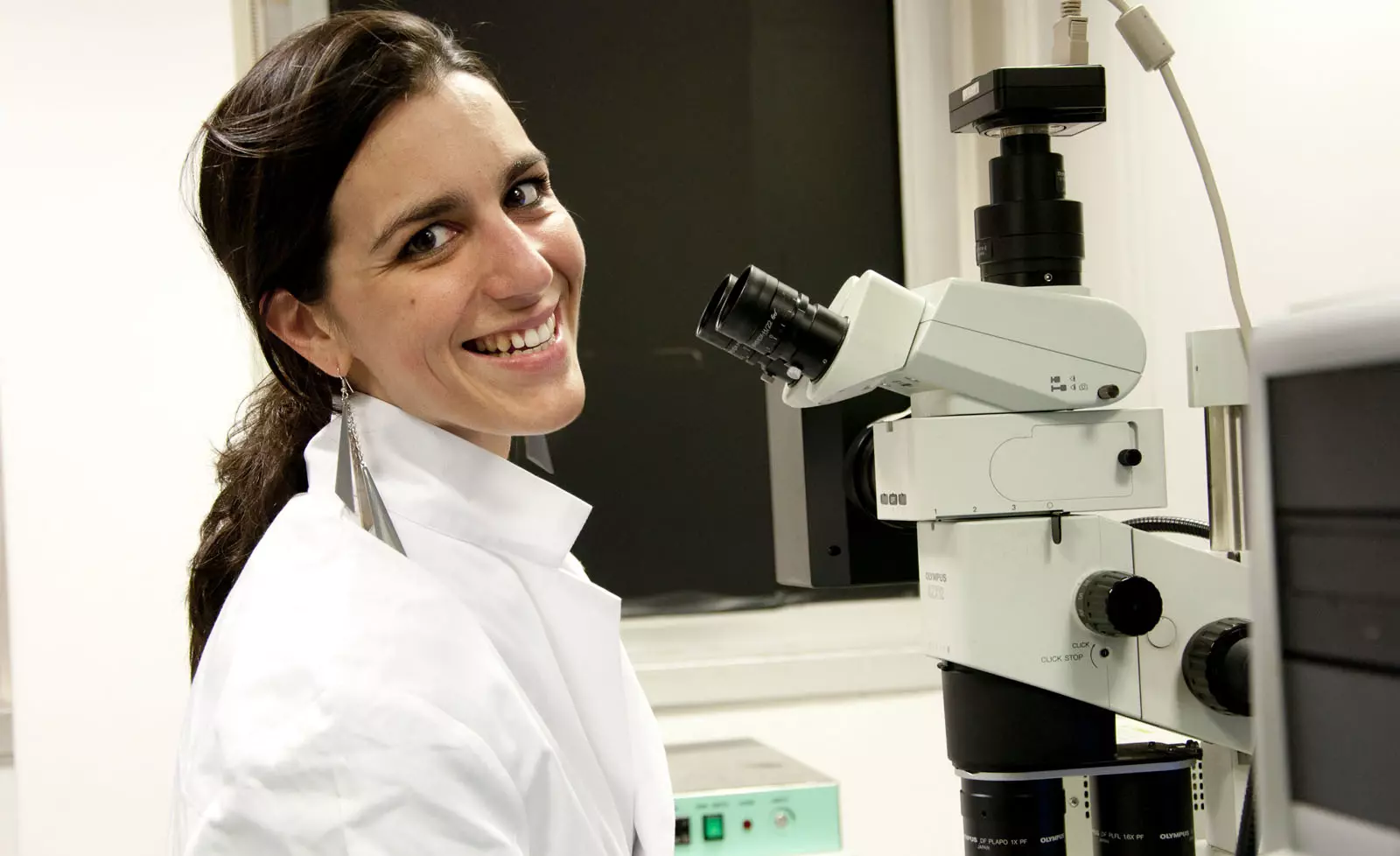L’evoluzione delle neoplasie mieloproliferative come modello più generale di metastasi
Il programma speciale 5 per mille Mynerva, coordinato da Alessandro Maria Vannucchi dell’Università degli Studi di Firenze, punta lo sguardo sui tumori mieloidi, in particolare i tumori mieloproliferativi cronici, le sindromi mielodisplastiche e alcuni tipi di leucemie acute. “Si tratta di neoplasie ematologiche rare se prese singolarmente, ma che nel loro insieme rappresentano una buona quota dei tumori che originano nel midollo osseo” spiega il medico ricercatore che da anni si occupa dello studio di queste patologie, anche grazie al sostegno di AIRC. Come ricorda il coordinatore del programma, i tumori mieloidi derivano dalle cellule staminali del midollo osseo. Possono presentarsi sin dall’inizio come forme aggressive oppure più comunemente come forme indolenti, che in alcuni casi possono andare incontro a un peggioramento e una trasformazione verso forme di difficile trattamento e rapidamente fatali. Il passaggio avviene attraverso l’evoluzione di alcune cellule del tumore che poi vengono selezionate e causano la proliferazione ulteriore della malattia e la sua diffusione nell’intero organismo. “In un certo senso questa evoluzione clonale mima i passi che portano un tumore dalla sua forma localizzata in un singolo organo a quella metastatica diffusa in sedi anche lontane da quella di origine” aggiunge Vannucchi. Nel corso del programma saranno analizzate non solo le cellule tumorali, ma anche il microambiente che le circonda e che può avere un ruolo nella selezione dei cloni aggressivi e nella loro disseminazione.
Gli obiettivi
Alla base del programma coordinato dal ricercatore toscano, al quale collaborano in totale sei unità sul territorio nazionale, c’è l’ipotesi che le neoplasie mieloidi rappresentino un modello in più fasi di progressione e diffusione della malattia, legato all’acquisizione di anomalie a livello del genoma. Queste anomalie a loro volta determinano, secondo i ricercatori, la selezione di particolari cloni all’interno della popolazione delle cellule staminali ematopoietiche, dalle quali derivano le cellule del sangue. Allo stesso tempo le anomalie alterano alcune caratteristiche del midollo osseo che permettono una normale formazione delle componenti del sangue. Tra gli obiettivi primari del progetto c’è quindi l’identificazione delle mutazioni e dei meccanismi genetici e molecolari presenti nelle diverse fasi dell’evoluzione clonale dei tumori mieloidi ad andamento cronico verso una patologia aggressiva. Si punta anche a comprendere come i cambiamenti del microambiente possono facilitare la diffusione della malattia, a individuare potenziali biomarcatori in grado di aiutare a prevedere la progressione, la diffusione del tumore e la sua aggressività, e a identificare bersagli contro i quali costruire terapie mirate da portare fino al paziente.
Il percorso
- Alla ricerca delle mutazioni più significative. Utilizzando le tecniche molecolari, biochimiche e cellulari più all’avanguardia, le unità operative coordinate da Vannucchi analizzeranno in dettaglio le caratteristiche delle cellule dei tumori mieloidi per cercare le mutazioni responsabili del passaggio da tumore indolente a malattia aggressiva e capace di diffondersi in tutto l’organismo. Per interpretare i dati che emergeranno da queste indagini, sarà necessario sviluppare anche metodi bioinformatici all’avanguardia.
- Il dialogo con il microambiente. Le stesse tecniche utilizzate per esaminare le cellule tumorali saranno applicate anche alle cellule del microambiente, attraverso le quali il tumore deve comunque muoversi per raggiungere sedi distanti, e che possono quindi avere un ruolo nella formazione e diffusione delle metastasi.
- Biologia e clinica entrano in contatto. I risultati ottenuti dagli studi sulle cellule del tumore e del microambiente saranno oggetto di ulteriori esperimenti di validazione sia in animali di laboratorio, sia nei numerosi campioni derivati dai pazienti e raccolti presso i diversi centri coinvolti nel programma. In seguito verranno progettati anche studi clinici nei quali valutare il ruolo dei biomarcatori e l’efficacia delle terapie mirate, identificate nelle fasi iniziali del programma.
- Una rete professionale e tecnologica. “Arrivare fino in fondo a questo programma di studi significa anche mettere insieme un gruppo di ricercatori in grado di condividere e armonizzare esperienze e competenze differenti, e sviluppare metodi specifici per raggiungere al meglio i singoli obiettivi” dice Vannucchi, che vede l’opportunità, grazie al programma sostenuto da AIRC, di costruire una rete tecnologica con centri di riferimento per l’oncologia italiana.
Perché è importante
L’incidenza delle neoplasie mieloidi è aumentata negli ultimi anni sia per l’invecchiamento della popolazione (sono malattie che si presentano più di frequente negli anziani) sia per il miglioramento delle tecniche di diagnosi con cui oggi si riescono a identificare come tumori mieloidi condizioni che prima rimanevano senza un nome preciso. “Molte di queste patologie, quando si modificano e assumono caratteristiche aggressive, sono difficilmente curabili” ricorda Vannucchi che, assieme ai colleghi, cerca soluzioni identificando nuove strategie di diagnosi e di terapie più precise e mirate. Dato che le neoplasie mieloidi con la loro evoluzione clonale rappresentano una sorta di modello generale per lo sviluppo di metastasi e la progressione del tumore, i risultati del programma potrebbero portare benefici anche a pazienti con altri tipi di cancro.
A che punto siamo
Aprile 2025. A questo punto del programma si intravedono i primi risultati concreti di molte delle linee di ricerca.
Lo studio del genoma delle cellule dei pazienti ha permesso di identificare la frequenza di mutazioni ricorrenti nel DNA che servono per classificare alcuni sottotipi di tumori mieloidi, per comprenderne le manifestazioni cliniche e predirne l’andamento clinico, facilitando le scelte terapeutiche. Si è compreso per esempio che alcuni geni mutati nelle neoplasie mielodisplastiche, come SRSF2 e SF3B1, influenzano il decorso della neoplasia anche in relazione ai loro tempi di insorgenza.
Inoltre l’analisi del DNA e dell’RNA delle cellule leucemiche, nelle forme derivate da una precedente neoplasia mieloproliferativa cronica, ha dimostrato che la leucemia compare in seguito all’acquisizione di ulteriori anomalie del DNA, tra cui in particolare a carico del gene TP53. Esistono già farmaci in grado di colpire alcune di queste anomalie, che oggi sono usati per le terapie di altri tipi di tumori, e che quindi potrebbero rivelarsi utili anche per trattare questo tipo di leucemie. Questi risultati potrebbero consentire inoltre una più precoce identificazione dei pazienti con malattia cronica a rischio di evoluzione leucemica, attraverso lo studio di queste mutazioni nel tempo.
In aggiunta, la messa a punto di innovative piattaforme di ultima generazione di sequenziamento massivo del DNA ha consentito ai ricercatori di scoprire nuove anomalie genetiche finora sconosciute. Tali nuove conoscenze possono facilitare l’identificazione dei pazienti con le forme più sfavorevoli di leucemia acuta, per i quali il trapianto di cellule staminali da donatore potrebbe rappresentare una precoce alternativa terapeutica.
Infine è stato completato lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per analizzare alcune mutazioni ereditarie, che rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo di tumori del sangue. Sono già state identificate diverse famiglie italiane con queste mutazioni, e la disponibilità della nuova tecnologia potrà migliorare molto la diagnosi di queste rare forme genetiche sul territorio nazionale. “Già da adesso diversi centri del programma Mynerva hanno messo a disposizione queste indagini molecolari per i loro pazienti, all’interno di ambulatori dedicati, dimostrando così una rapida transizione dalla ricerca di laboratorio alla pratica clinica più innovativa” precisa Vannucchi. Il coordinatore sottolinea inoltre come “i risultati ottenuti dalle indagini genomiche effettuate nel programma Mynerva siano già entrati a far parte di criteri diagnostici e prognostici adottati a livello internazionale per ottimizzare la gestione di questi tumori mieloidi.”
Anche sul fronte delle ricadute ci sono risultati interessanti. Lo studio del microambiente ha permesso di comprendere alcuni meccanismi che facilitano la localizzazione delle cellule tumorali in organi quali il polmone (per esempio nella leucemia promielocitica, dove questi processi possono causare danni anche fatali), la cute, la milza e altri. Si è peraltro aperta la possibilità di prevenire tali fenomeni mediante l’inibizione di alcune proteine, anche se questi studi sono ancora in fase iniziale. Si è inoltre compreso che l’alterata espressione di una proteina da parte delle cellule tumorali è responsabile della comparsa di tessuto fibroso nel midollo, che si realizza in particolare nella mielofibrosi, una delle neoplasie mieloproliferative croniche. Inibendo questa proteina si è riusciti a ridurre molto lo sviluppo di fibrosi in animali di laboratorio in cui si è cercato di riprodurre la malattia umana.
“Siamo poi molto entusiasti di come procedono le due sperimentazioni cliniche che sono state ideate e iniziate nel programma Mynerva. In un primo studio clinico stiamo cercando di valutare l’efficacia di una strategia più precisa e mirata per trattare i pazienti con leucemia acuta. Grazie alla collaborazione di molti altri centri ematologici italiani nella rete GIMEMA sono stati arruolati nello studio 150 pazienti, più dei due terzi di quelli necessari per dimostrare la validità della procedura. Ma soprattutto” aggiunge Vannucchi “abbiamo portato a compimento un secondo studio, in cui sono stati arruolati 109 pazienti con leucemia originata da un precedente tumore mieloide cronico. Nello studio, il più grande mai effettuato in questo gruppo di pazienti, è stata utilizzata una combinazione di due farmaci. L’analisi dei dati è ancora in corso, ma siamo fiduciosi che potrà dare informazioni importanti per queste rare e aggressive forme di leucemia. Va sottolineato che questi studi sono accademici, cioè indipendenti dall’industria e sono condotti grazie al solo sostegno di AIRC e con il supporto di GIMEMA. Nell’insieme hanno consentito di trattare in maniera innovativa pazienti con leucemia afferenti a decine di centri ematologici italiani.
“Anche questo testimonia l’impatto della ricerca finanziata da AIRC a favore dei pazienti con tumori mieloidi nel nostro Paese” conclude Vannucchi.
Un lavoro di squadra
La squadra del programma Mynerva comprende sei unità operative, ognuna indirizzata all’esplorazione di una parte del progetto generale con esperienza e capacità tecnologiche specifiche, ma con una forte valenza interattiva e collaborativa.
Il gruppo di ricercatori dell’Università di Pavia, guidati da Luca Malcovati, si concentra sulle sindromi mielodisplastiche, un’ampia e variegata famiglia di tumori ematologici, studiando le alterazioni del genoma che possono favorirne l’insorgenza o promuoverne l’evoluzione in leucemia acuta. Le alterazioni studiate possono anche costituire biomarcatori precoci della malattia.
Rossella Manfredini, dell’Università di Modena, utilizza le più avanzate piattaforme tecnologiche per descrivere il genoma e il profilo degli RNA delle cellule dei tumori mieloproliferativi, con l’obiettivo di scoprire mutazioni e meccanismi di attivazione cellulare che potrebbero rappresentare nuovi bersagli per terapie mirate. Attualmente è allo studio una proteina coinvolta nelle alterazioni fibrotiche del midollo di soggetti con mielofibrosi, uno dei tumori mieloidi cronici.
All’Università di Perugia, Cristina Mecucci e il suo gruppo stanno studiando le forme familiari dei tumori mieloidi, analizzando un certo numero di geni mutati, con metodi all’avanguardia, al fine di comprendere i meccanismi che sottendono allo sviluppo di una leucemia acuta. La capacità di identificare queste mutazioni potrà facilitare la gestione delle forme familiari di leucemia, aiutando a intervenire precocemente e più efficacemente.
Maria Teresa Voso, all’Università di Roma Tor Vergata, ha scelto di studiare una forma particolare di leucemia acuta, la leucemia promielocitica, un tempo detta anche leucemia fulminante (oggi questo nome è fortunatamente sempre più desueto, grazie ai risultati di molti studi di ematologi italiani anche sostenuti da AIRC). In particolare si vuole capire perché in alcuni casi le cellule leucemiche, dotate di particolare capacità di diffusione (“metastatica”), infiltrano non solo il midollo ma anche organi quali il polmone e il sistema nervoso centrale, causando disturbi potenzialmente fatali. Un secondo filone di ricerca sono le leucemie secondarie alle terapie, ossia quelle che possono insorgere in pazienti che hanno ricevuto, anche con successo, un precedente trattamento chemioterapico per un tumore solido. L’obiettivo è capire se, con lo studio del DNA, si possano identificare delle alterazioni che predispongono allo sviluppo della leucemia acuta secondaria.
Per approfondire
Visita il sito: http://www.progettomynerva.it/