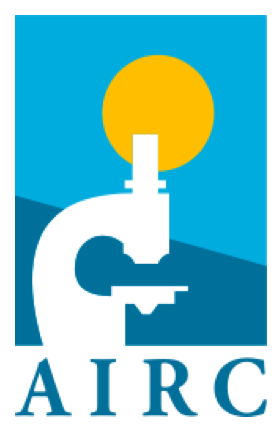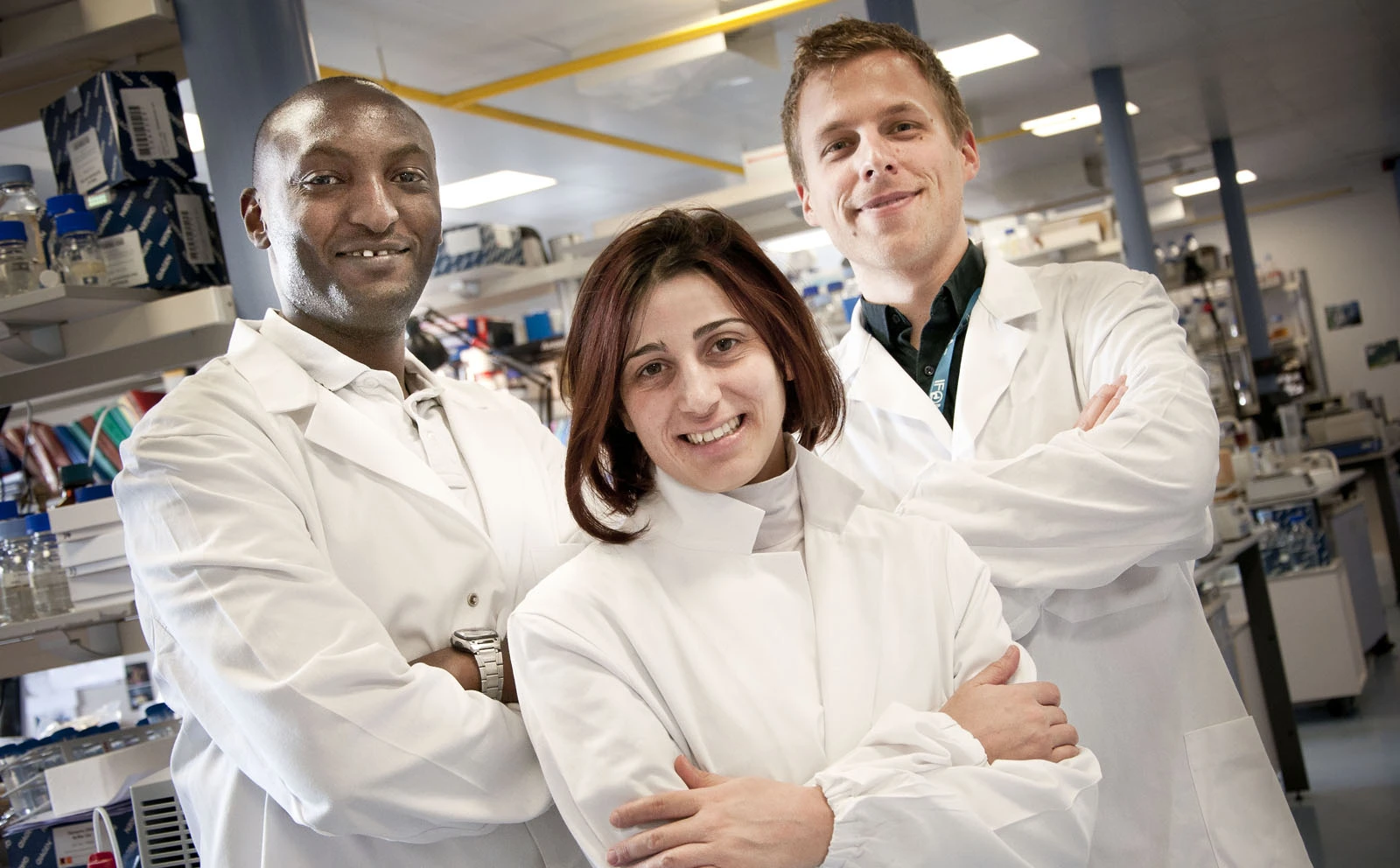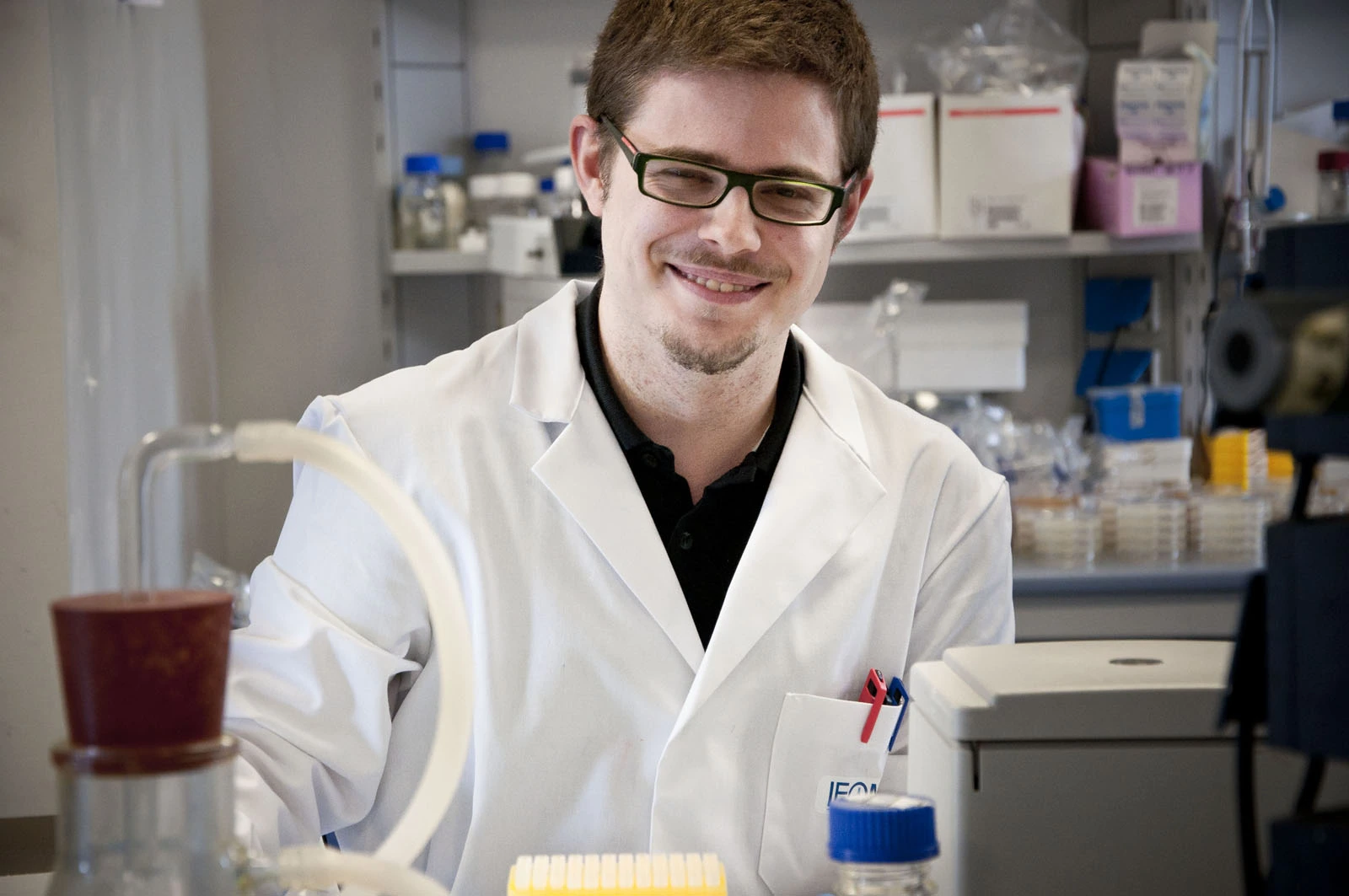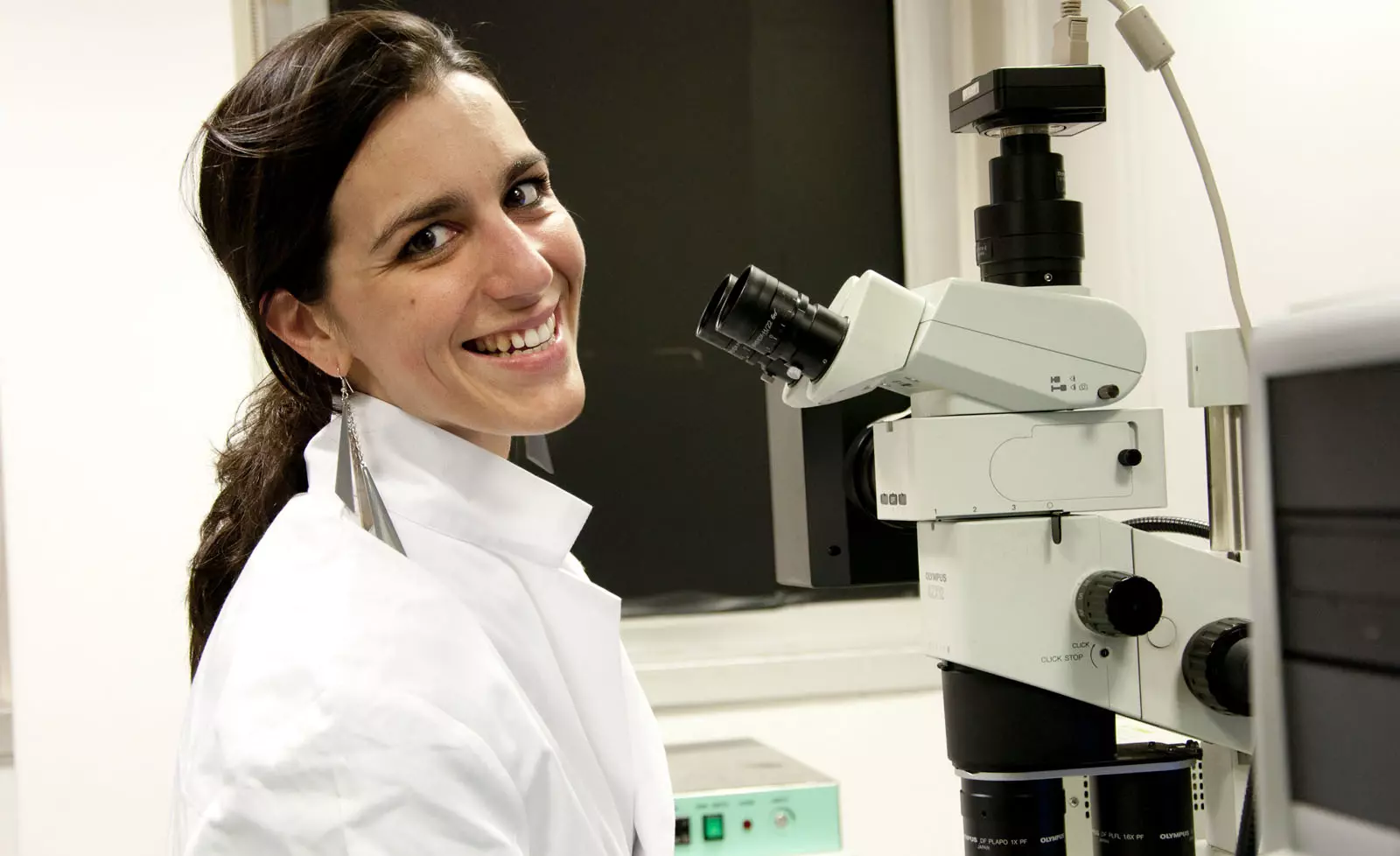Uno sguardo nuovo sulle metastasi, malattia “meccanica”
Per comprendere e attaccare un problema tanto importante come le metastasi bisogna cambiare prospettiva. Ne è convinto Stefano Piccolo, dell’Università di Padova e dell’Istituto fondazione di oncologia molecolare (IFOM), beneficiario di uno dei finanziamenti per i programmi 5 per mille AIRC dedicati proprio a questo problema. “Le metastasi sfuggono alla definizione di malattia con origine in mutazioni genetiche che ben si adatta alla maggior parte dei tumori primari. Per decenni i ricercatori in molte parti del mondo hanno cercato mutazioni specifiche, in queste cellule che migrano e crescono in organi diversi da quello di origine, senza particolare successo” spiega il ricercatore che, con la sua squadra formata da 17 gruppi attivi in 11 centri di ricerca, sta concentrando la propria attenzione in particolare sulle metastasi del tumore mammario. “Questa neoplasia oggi si cura con buoni risultati quando il tumore è soltanto primario. Le metastasi invece rappresentano una sfida irrisolta” aggiunge. Per cercare di affrontare tale sfida serve, secondo il gruppo guidato da Piccolo, una biologia nuova che tenga conto anche degli aspetti meccanici e fisici che influenzano il comportamento delle cellule metastatiche. “Grazie al sostegno di AIRC che ci accompagnerà per ben sette anni, potremo approfondire i dati preliminari oggi disponibili, che ci fanno ipotizzare la presenza di spinte di tipo meccanico alla base dei processi che portano le metastasi a stabilirsi in un determinato ambiente e a crescere fino a diventare letali” afferma il ricercatore.
Gli obiettivi
L’obiettivo principale del programma coordinato da Stefano Piccolo è comprendere a fondo il ruolo dei meccanismi di meccano-trasduzione nelle metastasi del tumore mammario. In altre parole, si tratta di capire come i segnali e le spinte di tipo meccanico e fisico siano in grado di dare alle metastasi quella sorta di superpotere che permette loro di crescere in ambienti diversi e ostili. Verranno studiate in particolare le caratteristiche del microambiente metastatico e sarà prestata grande attenzione al ruolo di molecole chiamate meccano-trasduttori, tra cui la molecola ATR, coinvolta nella riparazione dei danni al DNA, e di YAP e TAZ, la cui attivazione dipende proprio dagli stimoli meccanici che arrivano dal microambiente. Nel corso del programma si cercherà anche di identificare nuovi bersagli contro i quali indirizzare terapie mirate e nuove strategie terapeutiche che, agendo sugli aspetti meccanici delle metastasi, possano migliorare l’efficacia delle attuali cure, prima tra tutte l’immunoterapia.
Il percorso
Un dialogo fitto e complesso. La ricerca negli ultimi decenni ha stabilito che la progressione metastatica dei tumori dipende in larga parte dalle caratteristiche delle cellule tumorali e dalle loro interazioni anche di tipo fisico e meccanico con il microambiente nel quale le cellule si trovano. Proprio dal microambiente le cellule ricevono stimoli che ne influenzano il destino. “Sappiamo per esempio che il microambiente delle metastasi è caratterizzato dalla presenza di abbondante collagene, che rende questa porzione di tessuto fisicamente più dura. Noi pensiamo che questa caratteristica sia strumentale alla crescita delle metastasi” dice Piccolo. I ricercatori hanno quindi deciso di caratterizzare in modo dettagliato le interazioni non solo biologiche, ma anche e soprattutto meccaniche tra i diversi attori presenti in questo scenario, per comprendere meglio il dialogo in corso e magari trovare spunti per inserirsi in questa comunicazione, interrompendola o modificandola. “Identificare un segnale meccanico alterato in questo contesto rispetto alla norma significa trovare un punto potenzialmente debole delle metastasi e magari un bersaglio sul quale agire in modo mirato” spiega il ricercatore.
Studiare la meccanica attraverso i geni. Per studiare il fitto dialogo e la meccanicità delle cellule del tumore mammario, Piccolo e colleghi passeranno attraverso lo studio della regolazione dei geni all’origine delle proteine meccano-trasduttrici YAP, TAZ e ATR. Lavorando con campioni prelevati da pazienti e con cellule di laboratorio, i ricercatori vogliono verificare se e come le metastasi possano cambiare comportamento in funzione del microambiente in cui vengono poste. Tale microambiente sperimentale potrà avere caratteristiche diverse, per esempio essere più o meno duro. Un altro approccio sarà invece di agire sulle cellule, cambiandone le caratteristiche meccaniche in modo da permettere magari all’ambiente di agire su di esse, riportandole alla normalità o a un comportamento meno aggressivo. Per questa parte del programma verranno utilizzati campioni specifici ottenuti da singoli pazienti, che verranno analizzati in dettaglio grazie a tecniche avanzate e tecnologie all’avanguardia. Prima di arrivare a studi clinici con i pazienti, i risultati dovranno però essere anche valutati in animali di laboratorio.
Attaccare su più fronti. Muoversi su un solo fronte, modificando la “meccanicità” e agendo sulle cellule metastatiche o sul microambiente che le circonda, potrebbe non bastare a eliminare un tumore in modo definitivo. Proprio per questo motivo il programma prevede di valutare in studi clinici nuovi approcci terapeutici che agiscano su più fronti. Per esempio si proverà a combinare i trattamenti che colpiscono aspetti meccanici con strategie terapeutiche diverse, come l’immunoterapia. “Ci proponiamo di integrare i nostri studi sulla meccanicità con la risposta ai nuovi farmaci immunoterapici” afferma Stefano Piccolo, sottolineando che, al momento, l’immunoterapia è utilizzata solo in fase iniziale nel tumore mammario, con risultati spesso contrastanti. L’idea è inibire completamente le proprietà meccaniche delle metastasi o, viceversa, di spingere tali proprietà fino alle estreme conseguenze: forse uno “strappo” meccanico potrebbe renderle più riconoscibili da parte del sistema immunitario.
Perché è importante
Il tumore mammario è il cancro con il maggior numero di nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia (più di 55.000) e rappresenta circa il 30 per cento di tutte le diagnosi di tumore nelle donne. I risultati ottenuti nel corso del programma dovrebbero permettere di ottenere nuove strategie terapeutiche contro il tumore del seno metastatico, magari in combinazione con terapie già esistenti, e di individuare strumenti per una classificazione più precisa delle pazienti. Si tratta in entrambi i casi di agire sui segnali di tipo meccanico, che rappresentano una delle forze che portano alla nascita e alla crescita delle cellule metastatiche. “Spingendo lo sguardo oltre il tumore mammario, forse potremmo estendere i risultati che otterremo anche ad altri tipi di tumore, nei quali le cellule metastatiche possibilmente rispondono agli stimoli meccanici in modo simile” conclude Piccolo.
A che punto siamo
Aprile 2024. Il programma coordinato da Stefano Piccolo considera la malattia metastatica come un sofisticato ecosistema in cui anche le cellule tumorali più tenaci non potrebbero esistere da sole, ma solo in presenza di una costante relazione simbiotica con il microambiente tumorale che le circonda. Quest’ultimo è composto da diversi elementi, tra cui cellule non tumorali, attratte lì dai tessuti sani circostanti. Ma il microambiente è anche caratterizzato da una matrice extracellulare, composta da una vera e propria tessitura di filamenti di proteine, quali i diversi tipi di collagene che conferiscono ai tumori maligni e alle loro metastasi una elevata durezza. Tale ecosistema non è disposto in modo casuale nello spazio tridimensionale che contiene il tumore, ma segue una propria architettura e alcune proprie geometrie, dove nessuna relazione e contatto tra cellule e matrice extracellulare sono lasciati al caso. Scopo del programma è studiare le vulnerabilità intrinseche di questo ecosistema, ovvero gli stimoli del microambiente che permettono alle cellule tumorali di acquisire tratti metastatici. Il gruppo di ricerca ha scoperto che gli stimoli meccanici dalla matrice extracellulare hanno un ruolo fondamentale nel processo di metastatizzazione. Bloccare la meccanica tumorale rende benigni tumori inizialmente metastatici, mentre stimolare la meccanica tumorale induce tumori benigni a diventare maligni. I ricercatori stanno investigando i meccanismi molecolari e cellulari di questi intriganti fenomeni che sembrano specifici del processo metastatico. Si tratta di un passaggio in più, quello più letale, in cui una cellula tumorale si trasforma ulteriormente in un’entità ancora nuova, capace di colonizzare e crescere in organi distanti da quello di origine. Capire quali molecole si scambino le cellule in questa fase è fondamentale al fine di progettare strategie in grado di eliminare in maniera specifica le cellule metastatiche. In questi processi ha un ruolo essenziale il sistema immunitario. Il gruppo ha scoperto che gli stimoli meccanici sono cruciali per rendere il tumore “freddo”, cioè invisibile alle cellule del sistema immunitario. Ciò può avvenire per esempio bloccando un importante stimolatore dell’infiammazione, rappresentato dal gene cGAS. Risvegliare meccanismi come questo all’interno del tumore potrebbe rendere le cellule metastatiche più visibili da parte del sistema immunitario.
Un’altra rilevante conquista è stata possibile grazie all’utilizzo di nuove tecniche di trascrittomica spaziale, che permettono di individuare migliaia di geni attivi all’interno di ogni singola cellula, anche preservando la struttura architettonica del tumore, così cruciale per la sua malignità. In questo contesto, il gruppo di ricerca ha applicato tecniche di intelligenza artificiale proprio per mappare e ordinare le cellule che rispondono agli stimoli meccanici all’interno dei tessuti tumorali. Il contesto clinico in cui si innestano questi studi riguarda il tumore al seno meno curabile, quello detto triplo negativo. Esistono almeno due categorie di tumori tripli negativi. Un tipo, che non dà metastasi, è oggi abbastanza curabile con la chirurgia e le terapie farmacologiche standard. Un altro tipo, invece, dà origine a metastasi ed è ancora molto difficile da curare. Purtroppo, non è al momento possibile distinguere tra questi diversi tipi di tumore al momento della diagnosi. Risolvere questo enigma permetterebbe a molte pazienti con tumori non metastatici di evitare i danni di una chemioterapia a dosi maggiori rispetto alle loro esigenze e, dall’altro lato, di individuare pazienti ad alto rischio che avrebbero bisogno di cure ancora più aggressive o diverse. I ricercatori hanno scoperto che individuare stimoli meccanici in un tumore appena diagnosticato può aiutare a discriminare, fin dall’inizio, tra questi diversi tipi di tumore. Questi studi ora stanno proseguendo per essere validati su casistiche molto più ampie.
Un lavoro di squadra
Il gruppo coordinato da Stefano Piccolo nell’ambito del programma 5 per mille di AIRC dedicato allo studio delle metastasi è formato da 17 unità di ricerca dislocate su tutto il territorio nazionale. Fanno parte del consorzio l’Università di Padova, l’IFOM e l’Università statale di Milano, l’Istituto Mario Negri, l’Humanitas e l’Istituto nazionale dei tumori (INT), l’Istituto oncologico veneto (IOV) di Padova, l’Istituto Regina Elena di Roma, l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’ICGEB di Trieste e l’Università di Palermo.
Per affrontare la sfida ancora irrisolta delle metastasi serve infatti saper combinare una molteplicità di saperi e approcci e dedicarsi con dedizione a tematiche ancora poco conosciute.
Le ricerche che stanno realizzando i gruppi coinvolti nel programma partono da basi già consolidate in precedenza, come lo studio della molecola ATR, un meccano-trasduttore già noto per il suo ruolo nella riparazione dei danni al DNA e originalmente scoperto in questa funzione da Marco Foiani dell’IFOM di Milano.
Sempre all’IFOM, Vincenzo Costanzo è impegnato nella caratterizzazione di specifici programmi di attività che dipendono da ATR. Giorgio Scita studia i cambiamenti meccanici dell’ecosistema tumorale durante la progressione della malattia, mentre Silvia Marsoni si occupa di tradurre i risultati di laboratorio in applicazioni cliniche grazie alla sua ampia esperienza in questo campo. La progettazione degli studi clinici è guidata, per gli aspetti statistici, da Valter Torri dell’Istituto Mario Negri, mentre il loro coordinamento è di Valentina Guarneri, dell’Università di Padova e dell’Istituto oncologico veneto (IOV), con il contributo di Claudio Vernieri dell’INT e di Alberto Zambelli dell’Humanitas.
Rosario Rizzuto, all’Università di Padova, sviluppa sensori per studiare la risposta dei tessuti agli stimoli meccanici. Massimiliano Pagani, dell’Università di Milano, e Antonio Rosato, dello IOV, lavorano per creare la carta di identità sia delle cellule tumorali sia delle cellule con cui esse interagiscono. Pagani sta utilizzando la tecnica dell’analisi a singola cellula, di cui è uno dei pionieri, mentre Rosato sta sperimentando nuovi approcci in ambito immunopatologico. Giannino Del Sal, dell’ICGEB di Trieste, si sta occupando di studiare come avviene la comunicazione tra le componenti dell’ecosistema tumorale e delle metastasi e come questa sia influenzata dagli stimoli meccanici. Giovanni Blandino, dell’Istituto Regina Elena di Roma, sta creando “avatar” di tumori mammari e delle loro metastasi, ovvero versioni dei tumori specifiche di ogni paziente che possono essere studiate fuori dal corpo, anche per identificare farmaci per cui ogni paziente può dimostrare specifiche vulnerabilità.
Infine, grazie al contributo bioinformatico di Silvio Bicciato dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di patologi come Matteo Fassan dell’Università di Padova e Claudio Tripodo dell’Università di Palermo, il gruppo sta studiando a fondo le diverse caratteristiche manifestate dalle cellule tumorali in seguito a stimoli meccanici, valutando sul campo – ovvero in campioni ottenuti da pazienti – le ipotesi teoriche.
“Sono orgoglioso del nostro gruppo di colleghi, che unisce i migliori ricercatori di questo campo e li indirizza verso un obiettivo comune: combattere le metastasi colpendo il loro tallone d’Achille biomeccanico” dice Piccolo.