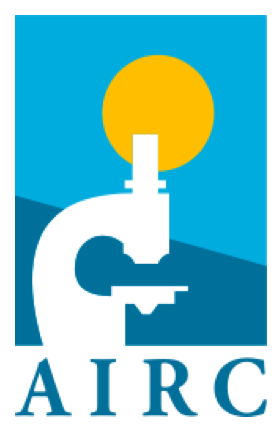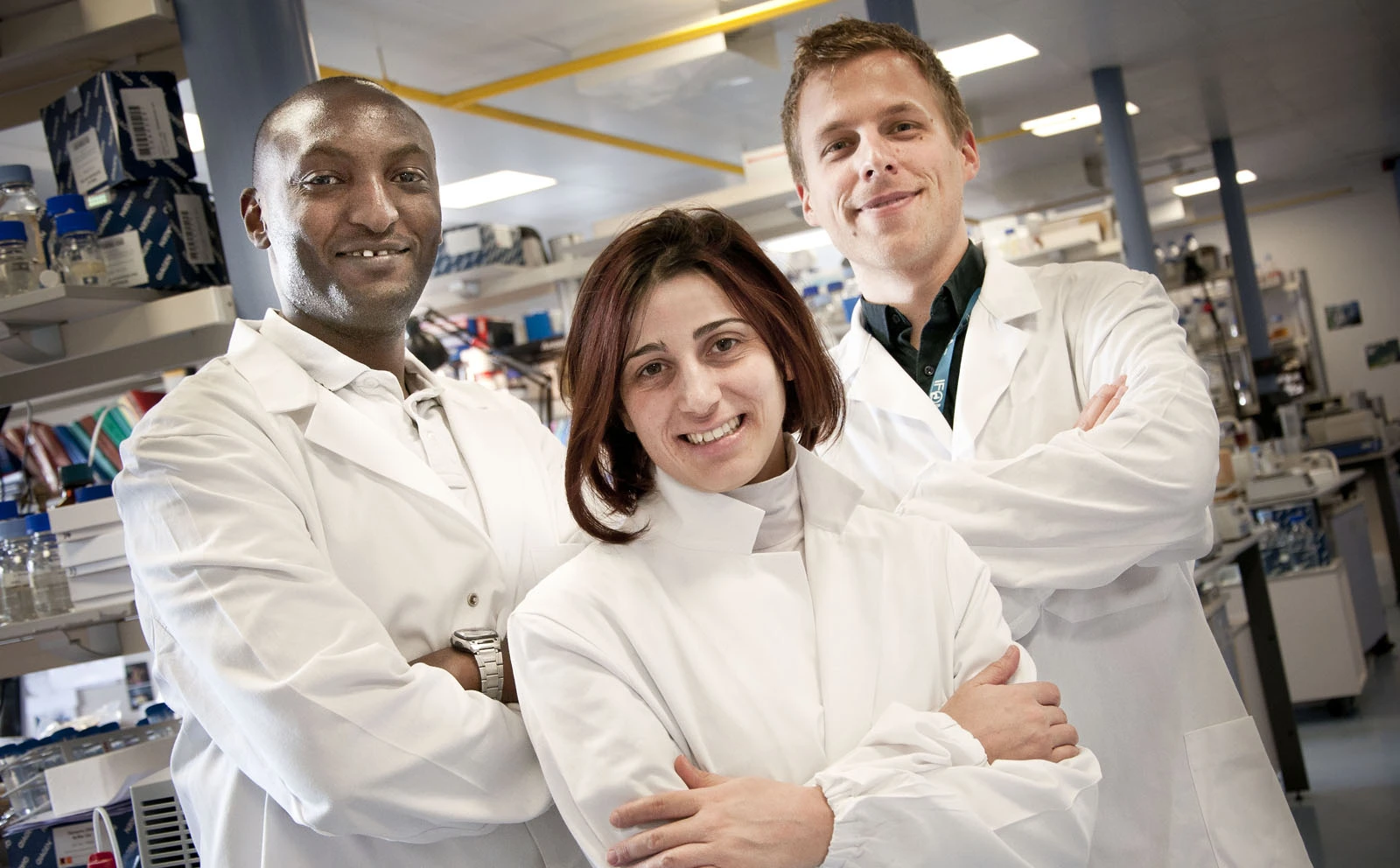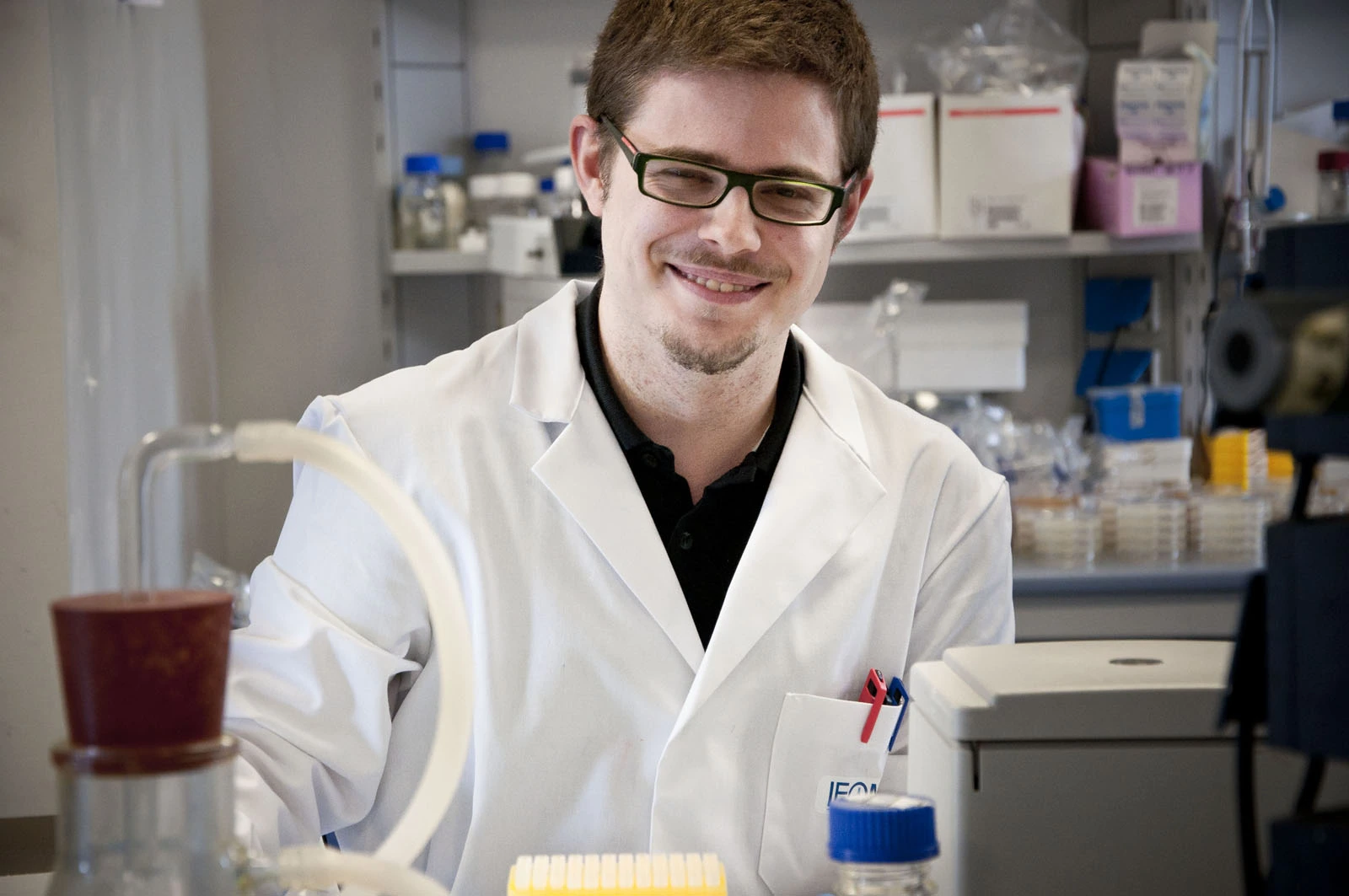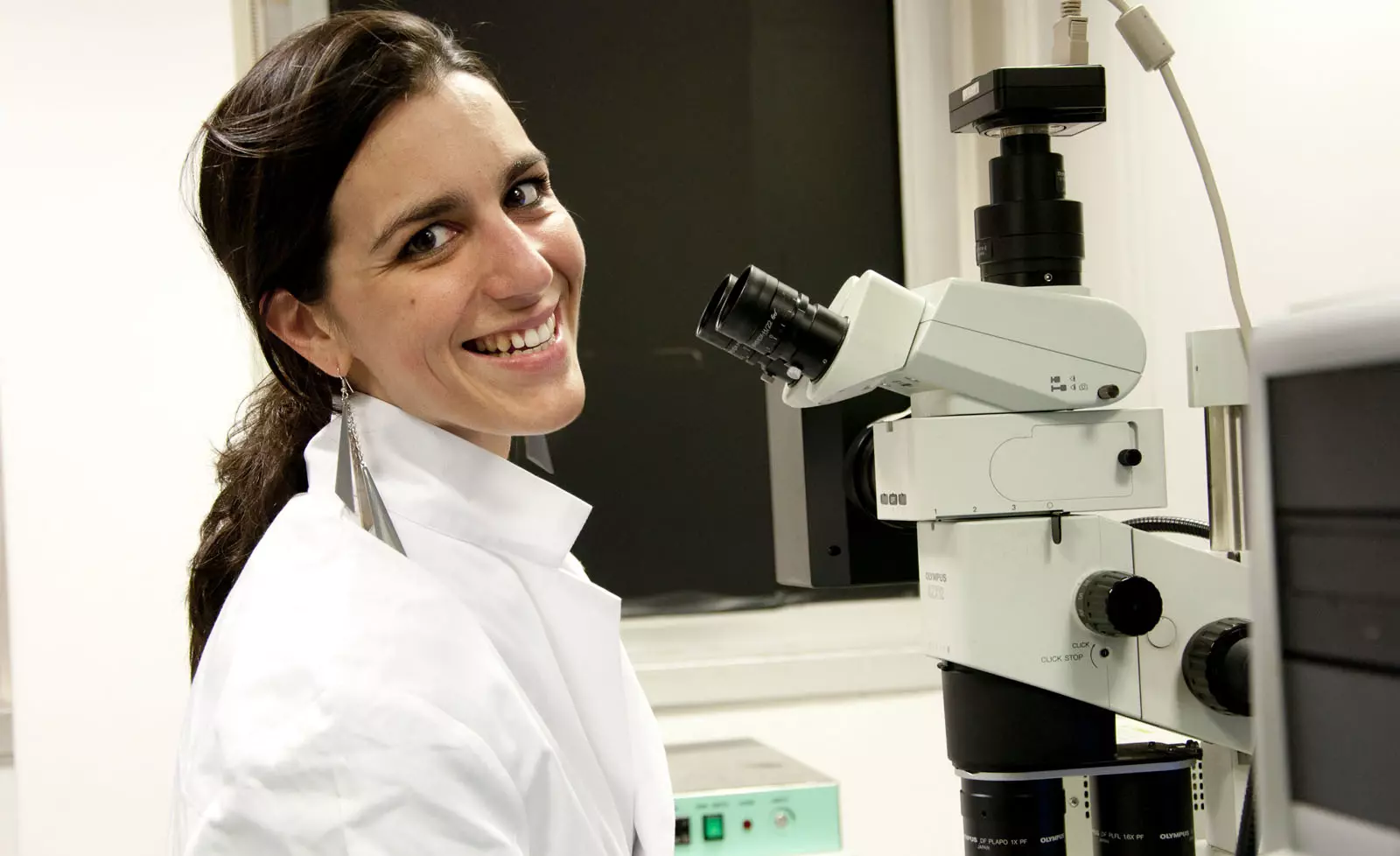Riflettori puntati sulle “metastasi” e sulla disseminazione di leucemie linfoidi e linfomi
Quando si ha a che fare con neoplasie linfoidi acute e croniche, come leucemie e linfomi, non si utilizza in genere il termine metastasi, riferito di norma ai tumori solidi, dato che i tumori del sangue sono per definizione diffusi. “In realtà anche nei tumori ematologici esiste la disseminazione e si assiste a volte a ricadute in sedi diverse da quella originale: ciò significa che le cellule tumorali si sono ‘spostate’ dalla sede iniziale e si sono localizzate in un’altra parte del corpo” spiega Robin Foà, che dalla Sapienza Università di Roma coordina uno dei programmi speciali 5 per mille sostenuto da AIRC e dedicato proprio allo studio della disseminazione in leucemie linfoidi e linfomi. Come ricorda Foà, la maggior parte dei pazienti riesce a raggiungere la remissione della malattia grazie alle strategie di cura oggi disponibili in ematologia. Nel tempo però alcuni pazienti possono andare incontro a ricadute anche in sedi diverse da quelle originali, sviluppando appunto delle metastasi. Il gruppo ha lavorato per anni sulla caratterizzazione genetica dei tumori linfoidi nell’ambito di un primo programma speciale 5 per mille sostenuto da AIRC, con lo scopo principale di migliorare la classificazione dei pazienti e di trovare strategie terapeutiche più mirate. Oggi i ricercatori coordinati da Foà si concentrano, in questo secondo programma speciale, sullo studio dei principi che guidano la resistenza della malattia e la sua disseminazione. I riflettori sono puntati su una più raffinata caratterizzazione genetica alla diagnosi, sulla correlazione dei sottogruppi identificati con la risposta alla terapia e sulla messa a punto di terapie differenziate. Particolare attenzione viene posta alla malattia residua minima, ovvero alle cellule che sfuggono in qualche modo alla terapia iniziale e che poi sono all’origine del ritorno della malattia. La presenza di queste cellule verrà associata alle caratteristiche genetiche rilevate alla diagnosi. Ma non è tutto. I ricercatori stanno lavorando attivamente sul sistema immunitario dei pazienti e su programmi di immunoterapia, come pure sul microambiente che circonda il tumore e può contribuire a sostenere la crescita della malattia e a proteggere le cellule cancerose dagli attacchi delle terapie. Il fine ultimo è ridurre i trattamenti chemioterapici in favore di terapie sempre più mirate e personalizzate.
Gli obiettivi
L’obiettivo finale del programma coordinato da Foà riguarda i pazienti con leucemie linfoidi acute e croniche e linfomi, e in particolare il miglioramento della loro sopravvivenza. I ricercatori hanno stabilito diversi traguardi intermedi da raggiungere, come la caratterizzazione del profilo genetico delle cellule alla diagnosi e di quelle resistenti al trattamento, e delle cellule che si ripresentano in aree diverse rispetto alla sede della malattia originale. I risultati aiuteranno a comprendere i meccanismi con cui alcune cellule tumorali riescono a resistere a trattamenti sempre più efficaci, a diffondersi e a colonizzare sedi diverse, magari con l’aiuto del microambiente tumorale, e il ruolo svolto dal sistema immunitario dei pazienti. Molecole o meccanismi individuati nel corso delle ricerche potrebbero diventare bersagli di nuove terapie da progettare in base alle informazioni raccolte, da valutare poi nella clinica. Grande rilievo viene dato a protocolli innovativi di trattamento, con particolare attenzione all’immunoterapia e a terapie sempre più mirate. Lo scopo ultimo è di arrivare a trattamenti meno incentrati sulla chemioterapia e sempre più indirizzati verso strategie terapeutiche che potenzialmente non ne prevedano l’uso (“chemio-free”).
Il percorso
- Diverse malattie, un approccio comune. Le neoplasie linfoidi sono state scelte come prototipi di un gruppo di tumori estremamente eterogenei, di cui fanno parte la leucemia linfoblastica acuta, la leucemia linfatica cronica, la leucemia a cellule capellute e i linfomi non-Hodgkin. Spiega Foà: “Leucemie linfoidi e linfomi sono tumori particolari che possono presentare anche all’interno della stessa patologia una serie di diverse anomalie genetiche non necessariamente note all’inizio del processo tumorale, ma che possono emergere nel corso della malattia e della progressione”. Foà ricorda anche come i singoli siti in cui il tumore si può diffondere possono avere caratteristiche diverse in termini di microambiente, tali da facilitare la diffusione della malattia e ostacolarne l’eradicazione. Le varie malattie, seppur diverse tra loro, saranno studiate con un approccio comune che i ricercatori hanno già sperimentato con successo negli anni precedenti.
- Tecnologie all’avanguardia. Nel corso del programma sono utilizzate alcune delle più avanzate tecnologie di analisi genetica e molecolare per completare le diverse fasi della ricerca, che parte dall’osservazione del paziente e della sua neoplasia –al momento della diagnosi, durante il decorso clinico e in caso di recidiva – per spostarsi in laboratorio e tornare infine in clinica con nuove strategie terapeutiche. Nel programma si usano tecnologie “high-throughput”, ovvero piattaforme che permettono di ottenere e analizzare un enorme numero di dati contemporaneamente e che saranno utili a definire i profili molecolari delle cellule tumorali e anche del microambiente che le circonda. Sono previste anche analisi del DNA libero circolante, per caratterizzare meglio il profilo genetico delle varie neoplasie in momenti diversi della malattia. Inoltre saranno effettuate analisi bioinformatiche e il monitoraggio attento della malattia residua minima, con studi genetici – anche su singole cellule – delle cellule neoplastiche residue. Verranno utilizzati speciali modelli tridimensionali di laboratorio, sviluppati facendo crescere cellule leucemiche e cellule provenienti da diversi microambienti in condizioni simili a quelle dell’organismo.
- Protocolli condivisi. Una delle caratteristiche dei programmi “5 per 1000” di AIRC è il coinvolgimento di numerosi centri con diverse competenze, che collaborano per raggiungere l’obiettivo finale. Nel caso del progetto coordinato da Robin Foà, questo approccio ha permesso di avere a disposizione un grande numero di campioni su cui lavorare attraverso protocolli condivisi. “Disponiamo di banche di tessuti e campioni biologici nei singoli istituti coinvolti nel consorzio e arruolati nei protocolli GIMEMA (Gruppo italiano malattie ematologiche dell’adulto), FIL (Fondazione italiana linfomi), HCL-PG” precisa Foà.
- Protocolli di terapia. Particolare rilievo viene dato al progetto e all’implementazione di protocolli clinici innovativi per diverse neoplasie linfoidi. Tali protocolli sono sempre più basati su trattamenti mirati a specifiche lesioni genetiche e su strategie di immunoterapia. La stretta interazione tra i laboratori, l’uso di tecnologie avanzate (vedi sopra) e la clinica sono fondamentali per la realizzazione di questi programmi terapeutici policentrici. In ultimo, questi studi permetteranno di cambiare gli standard di trattamento per diverse patologie.
Perché è importante
Gli studi di tipo genetico e molecolare sulle recidive dei tumori linfoidi sono in genere svolti proprio sulle cellule tumorali prelevate quando il tumore si è ripresentato. Nel progetto coordinato da Foà si punta invece a comprendere le differenze tra le cellule della malattia originale e quelle “superstiti” dopo la terapia, ovvero la malattia residua minima, che non rappresenta ancora una recidiva di malattia, ma ha un ruolo di primo piano nel ritorno e nella disseminazione del tumore. Conoscere a fondo queste differenze e le caratteristiche che consentono al tumore e al microambiente di dare il via al processo di metastatizzazione e disseminazione potrà essere utile a scovare il tallone di Achille delle cellule resistenti ai trattamenti. Proprio queste cellule potranno diventare il bersaglio di terapie innovative mirate a migliorare ulteriormente la prognosi dei pazienti con leucemie linfoidi acute e croniche e linfomi.
A che punto siamo
Aprile 2024. Il programma speciale 5 per mille di AIRC coordinato da Robin Foà si occupa di leucemie linfoidi acute e croniche e linfomi ed è ora nel suo sesto anno di attività. I lavori sono proseguiti come atteso e sono stati ottenuti risultati importanti. Ne ricordiamo alcuni.
Per quanto riguarda le leucemie linfoblastiche acute degli adulti, positive per il cromosoma Philadelphia (Ph+), un prolungato follow-up dei pazienti arruolati nello studio ha confermato i precedenti risultati estremamente positivi ottenuti con un trattamento di prima linea “chemo-free” ovvero senza l’impiego fi farmaci chemioterapici. Questo prevedeva una terapia di induzione mirata all’alterazione genetica Ph+, seguita da un consolidamento di immunoterapia con l’anticorpo monoclonale blinatumomab. I primi dati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine. È stato anche dimostrato che questa terapia combinata porta a un’attivazione del sistema immunitario dei pazienti, che potrebbe contribuire a mantenere la malattia sotto controllo. Il lavoro di follow-up a oltre 4 anni, recentemente pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, ha potuto documentare percentuali di sopravvivenza a lungo termine che si attestano tra il 75 e l’80 per cento. “La nostra strategia terapeutica è stata ripresa da molti altri centri di ematologia nel mondo. Nel lavoro appena pubblicato abbiamo altresì riportato che il 50 per cento dei pazienti non ha ricevuto chemioterapia né trapianto. Il protocollo nazionale GIMEMA attualmente in corso, che dovrebbe completare l’arruolamento entro un anno, dimostrerà in modo conclusivo quanti pazienti con leucemia linfoblastica acuta Ph+ potranno essere curati senza chemioterapia e senza trapianto” sottolinea Robin Foà. Come riportato a dicembre al congresso della Società americana di ematologia (ASH), l’aggiunta dell’anticorpo monoclonale blinatumomab sta avendo un impatto in termini di remissioni molecolari anche nei pazienti con leucemia linfoblastica acuta della linea B negativi per il cromosoma Philadelphia.
Per la leucemia linfatica cronica – la leucemia più frequente nell’emisfero occidentale – sono stati completati diversi studi, e altri sono in corso, con l’obiettivo di definire i fattori, soprattutto genetici, che aiutino a stabilire la prognosi e il grado di progressione della malattia. Questo diventa ancor più importante quando i trattamenti di prima linea per questa patologia sono sempre più basati su farmaci mirati, senza necessità di ricorrere alla chemioterapia. Sono altresì stati portati avanti studi sperimentali intesi a riprodurre il microambiente midollare, particolarmente nella leucemia linfatica cronica e nella leucemia a cellule capellute. Per quest’ultima patologia è in corso un protocollo nazionale per valutare se un approccio combinato di terapie mirate può essere più efficace rispetto alle terapie convenzionali.
Nei linfomi non-Hodgkin sono stati definiti algoritmi basati su profili genetici sempre più raffinati, che permettono di migliorare la caratterizzazione alla diagnosi e la stratificazione prognostica di diversi tipi di linfomi. Questo affinamento diagnostico e prognostico ha importanti implicazioni terapeutiche e apre la strada a una migliore comprensione dei meccanismi di disseminazione di diversi linfomi. Sono stati inoltre sviluppati modelli preclinici di linfomi a cellule T, che permetteranno di studiare e validare potenziali meccanismi genetici alla base di questo eterogeneo gruppo di tumori e di testare nuovi farmaci e nuove combinazioni terapeutiche.
Particolare attenzione è stata rivolta al monitoraggio della malattia residua minima nelle leucemie linfoidi acute e croniche e nei linfomi in diversi compartimenti – midollo osseo, sangue periferico, plasma –, utilizzando tecniche sempre più sensibili. I prossimi obiettivi sono: riuscire a meglio definire il grado di risposta alle terapie e le caratteristiche genetiche delle cellule residue; tenere sotto controllo la possibile disseminazione della malattia; e, in ultimo, personalizzare ulteriormente i percorsi terapeutici e ridurre/omettere quanto più possibile la chemioterapia.
Infine, è stato aperto un nuovo filone di ricerca per studiare i tessuti coinvolti nelle varie patologie, così da meglio comprendere le interazioni tra le cellule tumorali e le cellule normali in diversi compartimenti, a livello di analisi su singole cellule grazie alla “trascrittomica spaziale”.
Robin Foà, coordinatore del consorzio, conclude così: “Questa entusiasmante avventura dei programmi speciali 5 per mille AIRC, iniziata nel 2010 con il primo programma, sta proseguendo alacremente e con importanti risultati in questo secondo, che ne rappresenta la naturale continuazione ed evoluzione. È una grande soddisfazione vedere i progressi nell’inquadramento e nella stratificazione prognostica dei pazienti con leucemie linfoidi acute e croniche e linfomi alla diagnosi; nel monitoraggio progressivamente più raffinato della malattia durante le sue diverse fasi; nello sviluppo di tecnologie sempre più precise per valutare il profilo genetico delle diverse patologie e i meccanismi di possibile disseminazione; e infine nel progettare strategie terapeutiche sempre più innovative e basate sulle caratteristiche della diagnosi, sull’uso di trattamenti progressivamente più mirati e personalizzati, con l’aggiunta sempre più rilevante dell’immunoterapia. Tutto ciò sta avendo un evidente impatto sulla prognosi delle diverse patologie e si stanno attivando protocolli sempre meno basati sulla chemioterapia. È realistico ritenere che, attraverso questo approccio combinato e integrato, il lavoro delle tante persone che operano all’interno del gruppo porterà sempre di più a modificare la gestione clinica di diverse patologie linfoidi acute e croniche e a migliorarne la prognosi. Confidiamo infine che lo sviluppo tecnologico a livello di comprensione dei rapporti tra le singole cellule tumorali e le cellule normali del paziente, che condurremo nella parte conclusiva del nostro programma speciale 5 per mille di AIRC, potrà ulteriormente migliorare le nostre conoscenze e le nostre possibilità di controllo della malattia nelle diverse neoplasie linfoidi”.
Un lavoro di squadra
Il consorzio di ricerca coordinato da Robin Foà comprende cinque unità operative. Oltre al gruppo della Sapienza Università di Roma, coordinato dallo stesso Foà, ci sono le unità dirette da Enrico Tiacci dell’Università di Perugia, da Gianluca Gaidano, dell’Università del Piemonte orientale a Novara, da Paolo Ghia, dell’Università San Raffaele a Milano, e da Stefano Pileri, dell’Istituto europeo di oncologia (IEO) a Milano.
Un lavoro di squadra che dura da anni e si è sempre più consolidato nel tempo. Quattro unità – quelle dirette da Foà, Tiacci, Gaidano, Pileri – collaboravano già tra loro in un precedente programma AIRC 5 per mille. Questo network funzionale, che coinvolge 50-60 persone, ha garantito negli anni la continuità e l’evoluzione delle varie linee di ricerca.
Il consorzio, fin dal primo progetto AIRC 5 per mille, ha focalizzato le proprie ricerche sui disordini linfoproliferativi acuti e cronici, in particolare sulla leucemia acuta linfoblastica (LAL), la leucemia linfatica cronica (LLC), la leucemia a cellule capellute (HCL) e i linfomi non-Hodgkin (LNH). Sono sempre stati affrontati problemi dalle importanti implicazioni cliniche, con l’obiettivo di raffinare l’inquadramento diagnostico e la stratificazione prognostica dei pazienti, e di progettare strategie terapeutiche innovative. L’interazione tra i gruppi è stata una costante durante tutte le fasi del progetto e un valore aggiunto.
Più in dettaglio, l’Unità della Sapienza a Roma ha avuto come principali campi di interesse la LAL e la LLC. Gli studi sulla LAL, in particolare sulle LAL positive per il cromosoma Philadelphia, hanno avuto una valenza nazionale e hanno coinvolto le unità di Novara e Perugia. I progetti sulla LLC sono stati portati avanti soprattutto in collaborazione con l’unità di Novara. Il gruppo di Roma ha altresì condotto studi sull’impatto della pandemia da Covid-19 su LAL e LLC, in collaborazione con le unità del gruppo, soprattutto quella del San Raffaele a Milano.
L’Unità di Perugia ha avuto come principale campo di interesse la HCL e ha coordinato innovativi protocolli terapeutici nazionali che hanno viste coinvolte altre unità del consorzio (Roma, Novara). Inoltre ha avviato una collaborazione con l’unità del San Raffaele per studi preclinici sulla HCL.
L’Unità di Novara ha avuto come interesse primario la LLC e i LNH, in collaborazione soprattutto con i gruppi della Sapienza e dell’IEO. Ha altresì collaborato ai progetti sulle LAL coordinati dalla Sapienza e sulla HCL coordinati da Perugia.
L’Unità del San Raffaele a Milano si è interessata principalmente alla LLC attraverso protocolli terapeutici innovativi e studi di laboratorio che permettono di coltivare cellule di LLC ottenute dai pazienti. I protocolli clinici coinvolgono altre unità del consorzio e gli studi con cellule in coltura sono stati estesi alla HCL in collaborazione con Perugia.
Infine, l’Unità dell’IEO a Milano ha ulteriormente raffinato l’inquadramento diagnostico e la stratificazione prognostica di diverse forme di LNH. Collaborazioni sono da tempo in essere con le unità di Novara, Perugia e Roma.
Nell’ambito dei diversi gruppi, notevole priorità è stata sempre data alla formazione e alla crescita di giovani, molti dei quali sono diventati ricercatori autonomi e affermati, una garanzia per la continuità nel tempo delle attività di ricerca in corso. I risultati, documentati dalle numerose pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche, sono a sottolineare quanto ottenuto attraverso questo intenso “lavoro di squadra”.