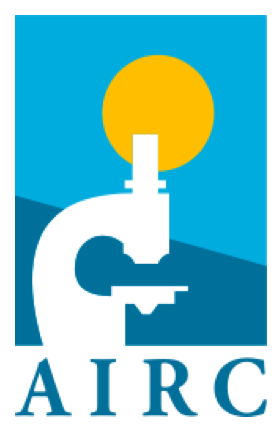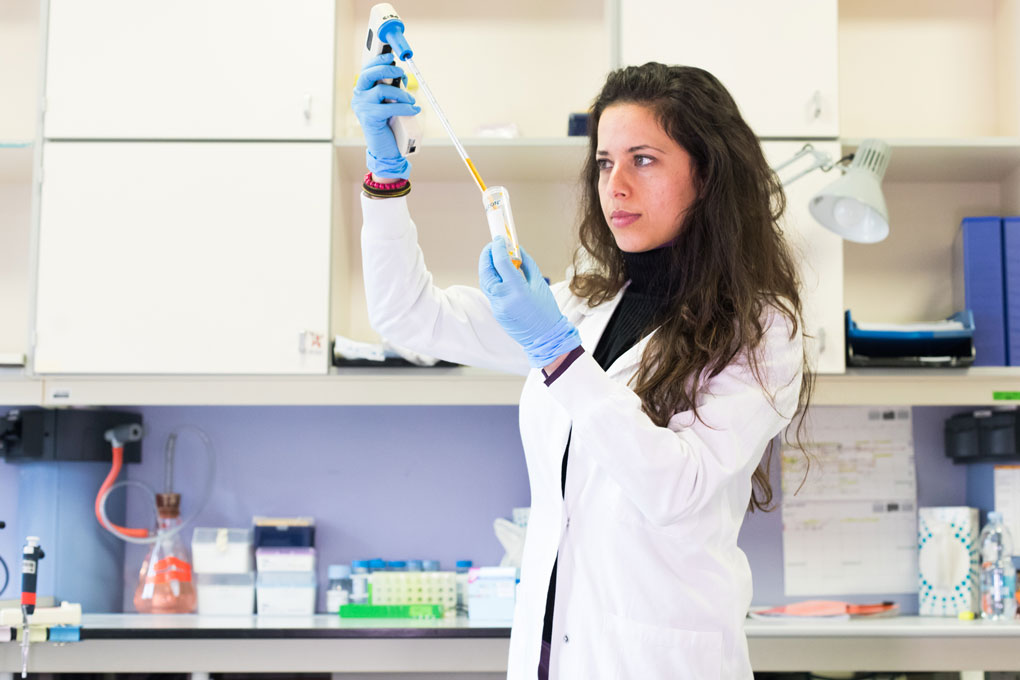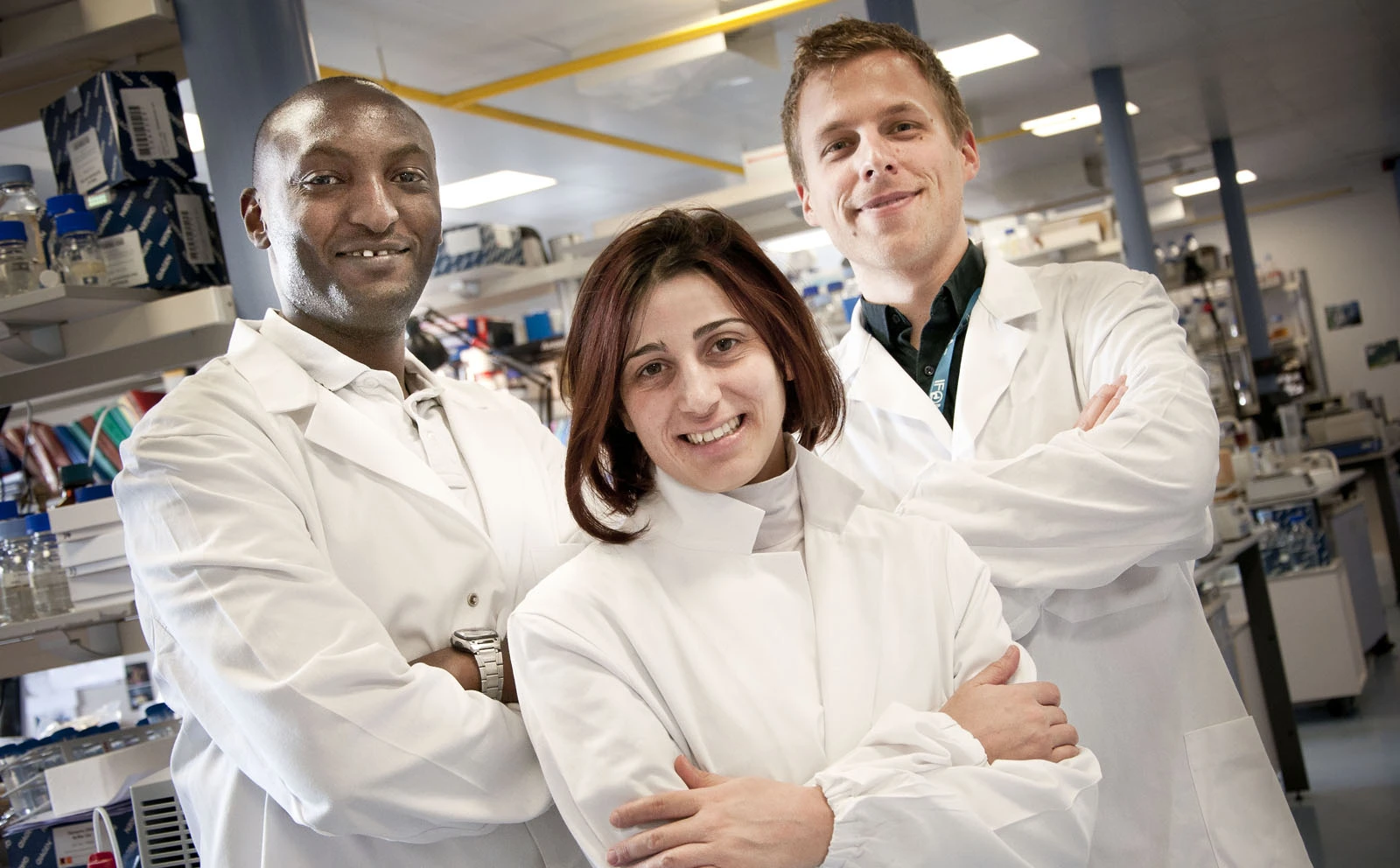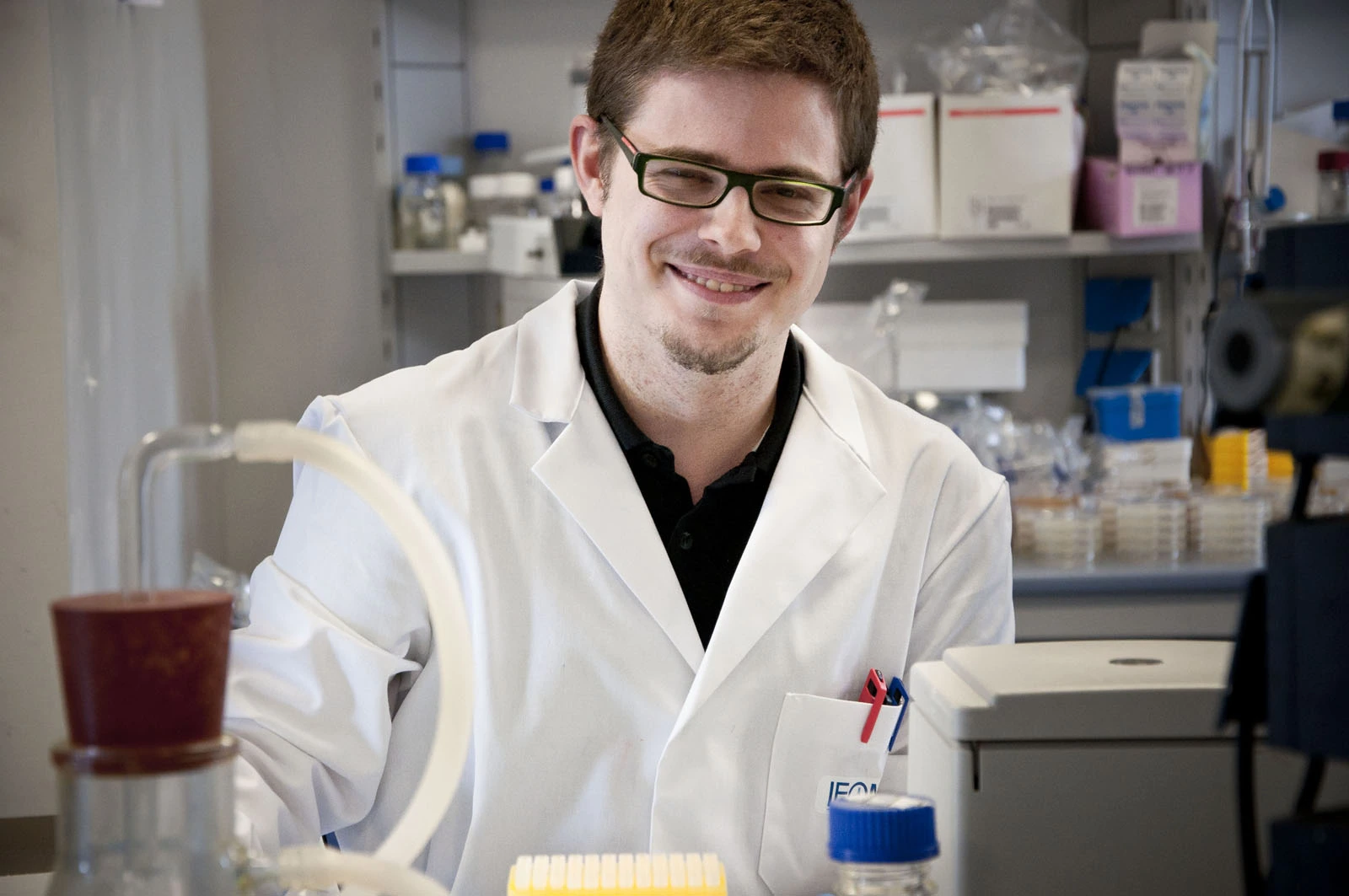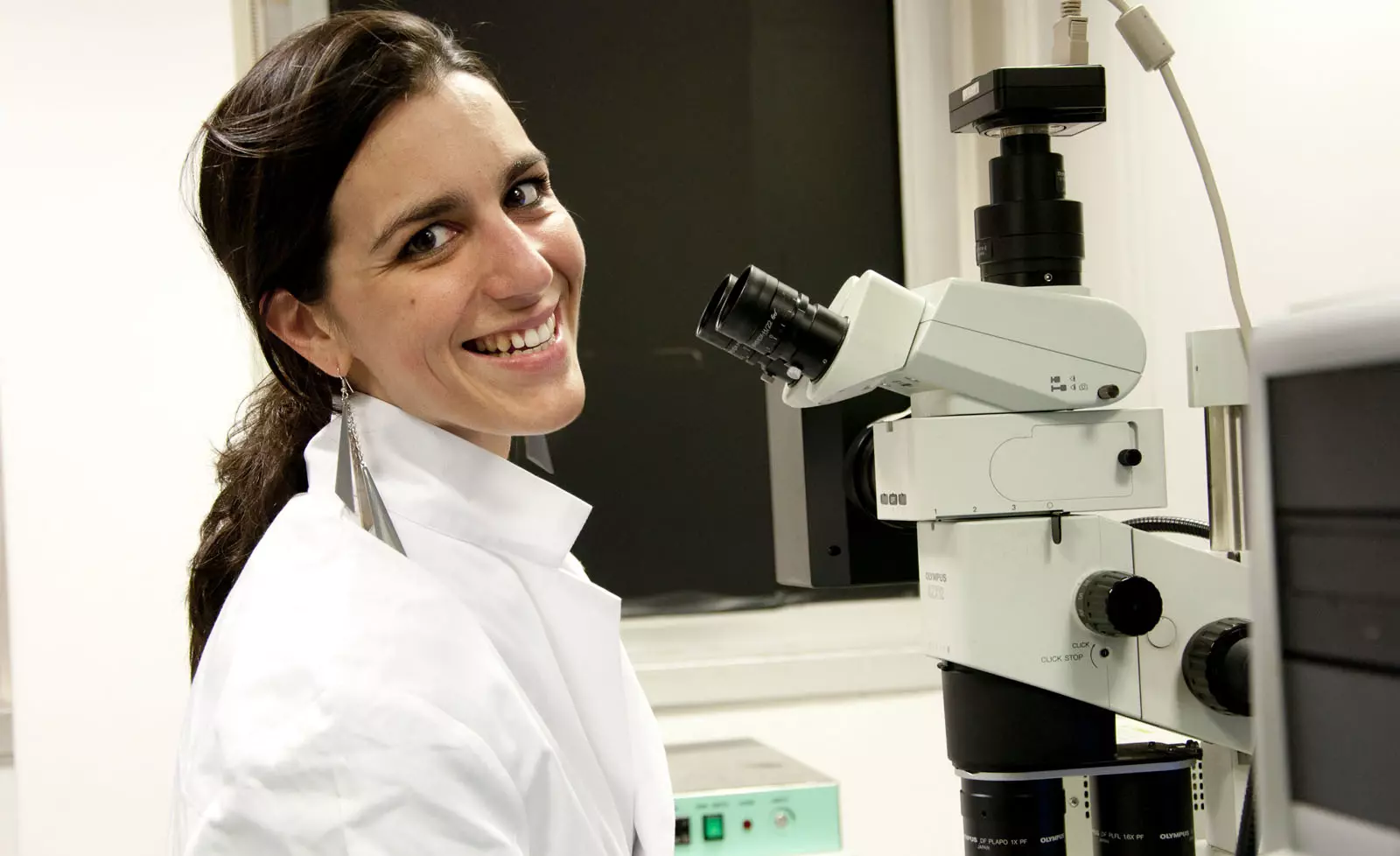Le terapie immunitarie più avanzate contro le metastasi del fegato
Il programma di ricerca guidato da Maria Chiara Bonini, dell’Università vita-salute Ospedale San Raffaele di Milano, si concentra sulle metastasi al fegato originate dai tumori del colon-retto e da quelli del pancreas. Coinvolge in totale 18 gruppi di ricerca, tutti affiliati all’istituto milanese. “Siamo partiti da quello che gli inglesi chiamano un ‘unmet need’, un bisogno ancora insoddisfatto che riguarda i pazienti con il tumore colorettale e l’adenocarcinoma duttale del pancreas. Si tratta delle metastasi al fegato che originano da questi due tumori e che a oggi sono difficili da curare” spiega la ricercatrice. La scelta di puntare proprio su colon-retto e pancreas, ricorda Bonini, è legata anche alla grande esperienza che il San Raffaele può vantare nel trattamento di queste patologie, e che è valorizzata dal contributo di Luca Aldrighetti, Massimo Falconi e Michele Reni, i coordinatori clinici del programma. “Non dobbiamo inoltre dimenticare che questi tumori si collocano ai primi posti per i decessi per cancro e che le metastasi al fegato ne sono spesso la causa” aggiunge. Forti anche dell’esperienza con le terapie immunologiche più avanzate, Bonini e colleghi hanno deciso di dare vita a un programma ambizioso che sarà sostenuto per un totale di 7 anni, con verifiche intermedie, tramite i contributi del “5 per mille” destinati ad AIRC dai contribuenti. “Il programma rispecchia ciò che secondo noi c’è da fare per affrontare il problema delle metastasi epatiche, e abbiamo potuto pensare in grande proprio grazie al sostegno, unico per entità e durata, che AIRC ci ha voluto garantire” conclude Bonini.
Gli obiettivi
L’obiettivo ultimo dei ricercatori coinvolti in questo programma “5 per mille” è lo sviluppo di nuovi prodotti terapeutici basati sulle terapie geniche e cellulari che coinvolgono direttamente il sistema immunitario. Si tratta di utilizzare strategie innovative e le più avanzate tecnologie molecolari, cellulari e genetiche per arrivare a contrastare in modo efficace le metastasi al fegato derivate dai tumori di colon-retto e pancreas. Tali strategie dovrebbero modificare anche il microambiente, che è in grado di favorire la crescita delle cellule tumorali metastatiche e di ridurre l’efficacia delle terapie disponibili.
Il percorso
- Un passo indietro… verso il futuro. Come spiega Paolo Dellabona, coordinatore della prima parte del programma, lo studio iniziato nel 2019 si fonda su due pilastri terapeutici che utilizzano il sistema immunitario sotto forma di cellule (linfociti T) o di molecole (citochine). I ricercatori si sono però accorti che il microambiente delle metastasi tumorali, contro le quali queste terapie dovrebbero agire, resta in gran parte sconosciuto. “Abbiamo pensato quindi di fare un passo indietro e di andare a caratterizzare in modo estremamente dettagliato il microambiente che si genera nel fegato quando sono presenti metastasi dei tumori di colon-retto e pancreas” aggiunge Dellabona. Per raggiungere questo traguardo, che permetterà di ottenere informazioni essenziali anche per lo sviluppo delle altre fasi del programma, è previsto un approccio multidimensionale (a livello molecolare, cellulare e tissutale) che può fornire una visione globale anche di nuovi meccanismi da prendere in considerazione per migliorare l’efficacia delle terapie.
- “Educazione cellulare” contro il cancro. I linfociti T sono i protagonisti della parte del programma dedicata alla cosiddetta “immunoterapia adottiva”, in cui alcune cellule immunitarie, e in particolare i linfociti T, saranno “ingegnerizzate”, ovvero modificate appositamente perché riconoscano quelle tumorali, sopravvivano all’ambiente generato dal tumore nelle metastasi epatiche di colon-retto e pancreas ed eliminino le cellule tumorali. In un certo senso, i ricercatori vogliono educare i linfociti T a svolgere una serie di compiti almeno in parte nuovi, che verranno definiti anche in base ai risultati ottenuti nella prima fase del programma. “Negli anni abbiamo imparato a ingegnerizzare queste cellule: possiamo inserire o eliminare geni, possiamo modificare la specificità e il riconoscimento di particolari molecole. Useremo queste competenze per mettere a punto terapie cellulari capaci di eliminare il tumore e continuare ad avere effetti a lungo termine nei pazienti” spiega Bonini, ricordando che le strategie messe a punto verranno sperimentate in animali di laboratorio prima di studiare le più promettenti nei pazienti.
- È ora di cambiare (micro)ambiente. Anche le citochine immunostimolatorie, molecole capaci di attivare le difese e potenti armi contro il tumore, hanno un ruolo da protagoniste in questo programma di ricerca. In particolare, i ricercatori coordinati da Luigi Naldini puntano a modificare il microambiente tumorale proprio utilizzando queste molecole, portate direttamente al fegato da vettori lentivirali appositamente creati. I vettori lentivirali sono derivati dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV), appositamente modificato a livello genetico in modo da essere reso innocuo e sicuro e da funzionare quale mezzo per introdurre specifici geni terapeutici in particolari tipi di cellule, in questo caso tumorali. “Somministrare citochine immunostimolatorie a livello sistemico come si fa con la chemioterapia porta con sé effetti collaterali importanti. Per questa ragione abbiamo costruito speciali vettori che vengono intercettati solo dalle cellule del fegato e possono portare direttamente le citochine solo dove servono” spiega Naldini. Grazie alle informazioni emerse nel corso del programma, questo vettore potrà diventare ancora più specifico e puntare alle metastasi epatiche per modificare il microambiente e spianare la strada ad altre terapie (magari proprio i linfociti T ingegnerizzati) da usare in combinazione. Ma non è tutto. I ricercatori vogliono generare veri e propri interruttori molecolari che possano “accendere” o “spegnere” la citochina, rendendo ancora più precisa, sicura e mirata l’azione della terapia.
- In viaggio verso i pazienti. L’ultima parte del programma, che in realtà rappresenta solo l’inizio di una fase più direttamente legata ai malati, riguarda il trasferimento in clinica dei risultati ottenuti in laboratorio. “È un aspetto molto importante e per nulla scontato del nostro programma” spiega Bonini, ricordando che il primo passo è definire quali siano le strategie più efficaci e sicure per i pazienti. Per arrivare in fondo è necessario seguire un iter burocratico e tecnico molto preciso e impegnativo, che richiede tempo e risorse, ma che a conti fatti non spaventa i ricercatori milanesi. “Anche per questa parte del lavoro possiamo contare su una grande esperienza e una struttura ben equipaggiata. Non dimentichiamo che il primo prodotto cellulare ingegnerizzato e approvato per pazienti con malattie neoplastiche dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è nato proprio al San Raffaele” aggiunge.
Perché è importante
Introdurre nuove strategie per contrastare le metastasi al fegato derivate dai tumori di colon-retto e pancreas significa in primo luogo migliorare la prospettiva di vita di tanti pazienti che ancora oggi si ammalano di queste due malattie. I risultati ottenuti nel corso del programma potranno però rivelarsi utili anche in scenari diversi e per altri tipi di tumore. “La scelta di un unico organo, il fegato, e di due tumori diversi, del colon-retto e del pancreas, nasce proprio dall’idea di poter esportare le strategie più efficaci anche alla cura di altre neoplasie, dopo i dovuti aggiustamenti” spiega Bonini. “Dal confronto emergono infatti sia le differenze sia gli aspetti comuni alle diverse patologie metastatiche. Aspetti che sarà possibile valutare anche in altri tipi di tumori” conclude.
A che punto siamo
Aprile 2025. Il programma “5 per mille” coordinato da Chiara Bonini procede spedito e con rinforzato entusiasmo, avvicinandosi sempre di più agli obiettivi da raggiungere.
Il protocollo clinico LiMeT, partito con l’avvio del programma, conta oggi quasi 1.000 pazienti arruolati e rappresenta una miniera, per la varietà di campioni biologici raccolti dai pazienti, le informazioni cliniche e sulle terapie ricevute fino all’entrata nello studio, nonché per i dati di follow-up dei successivi 3 anni. “La casistica LiMeT è servita per caratterizzare dal punto di vista immunologico e molecolare le metastasi epatiche e per identificare e validare i bersagli delle nostre nuove terapie” chiarisce Paolo Dellabona, coordinatore di questa parte del programma. “Negli anni abbiamo studiato gli effetti del tipo di chemioterapia sulla risposta immunitaria antitumorale locale e cercato analogie e differenze macroscopiche tra il microambiente del fegato metastatico nei tumori del colon-retto e del pancreas. Ora ci stiamo concentrando su un’analisi più fine e sfrutteremo le ultime tecnologie sviluppate nel campo delle analisi ‘spaziali’, per chiarire come la posizione all’interno del fegato e rispetto agli altri tipi cellulari influenzi le caratteristiche e il comportamento delle singole cellule. Disponendo anche di campioni biologici prelevati in momenti successivi (longitudinali) del decorso clinico di molti pazienti, indagheremo anche l’aspetto temporale”. Chiara Bonini aggiunge: “La possibilità di contare sulla biobanca istituzionale, in cui fin dall’inizio dello studio sono stati conservati i campioni biologici dei pazienti, permetterà di rianalizzare i campioni più importanti con tecnologie sempre più avanzate e possibilmente di rispondere a domande irrisolte. Per questo motivo il protocollo LiMeT sarà portato avanti anche dopo la fine del programma AIRC ‘5 per mille’, per sostenere gli altri progetti di ricerca che ne sono derivati”.
La parte del programma dedicata all’ingegnerizzazione genetica dei linfociti T, coordinata da Chiara Bonini, ha generato un’estesa gamma di strumenti per modificare i linfociti T dei pazienti, così da rendere tali cellule capaci di individuare le metastasi e di difendersi dai meccanismi immunosoppressivi presenti nel fegato con metastasi. “Gli esperimenti con cellule in coltura e topi di laboratorio hanno dimostrato una maggiore efficacia dei linfociti ingegnerizzati rispetto a quelli non ingegnerizzati. Si è così evidenziata la necessità di apportare più di una modifica ai linfociti T dei pazienti per risvegliare la loro attività antitumorale fiaccata dal tumore” spiega Chiara Bonini. “Ora stiamo validando il profilo di sicurezza dei prodotti cellulari più efficaci, per escludere ogni rischio di tossicità per cellule e tessuti sani.”
Anche la parte del programma coordinata da Luigi Naldini, volta alla modifica del microambiente tramite l’uso di geni o piccole molecole come i peptidi, ossia brevi sequenze di aminoacidi, sta consentendo di scegliere tra i prodotti finora sviluppati i candidati più promettenti in termini di sicurezza ed efficacia. Da un lato, i ricercatori hanno messo a punto speciali vettori virali per applicare la terapia genica direttamente alle cellule del fegato, che così diventano capaci di produrre citochine, ossia molecole in grado di stimolare un’efficace risposta immunitaria antitumorale proprio nel sito del tumore. In tal modo è possibile evitare gli effetti avversi causati da tali molecole somministrate in modo convenzionale. I migliori risultati sono stati ottenuti con la citochina interferone alfa. Dall’altro lato, i ricercatori hanno identificato un peptide capace di legarsi a due entità biologiche: alle integrine, una classe di molecole espresse sulla superficie delle cellule di alcuni tumori (tra cui quelli del pancreas e del colon-retto), ma non sulle controparti sane; e ad alcune cellule immunosoppressive, che favoriscono la progressione tumorale. Tale peptide rappresenta dunque una sorta di jolly, perché può essere coniugato a molecole con funzioni diverse (farmaci citotossici, citochine, traccianti fluorescenti o radioattivi), che così sono veicolate solo sulle cellule legate dal peptide, sulle quali svolgono la loro attività, risparmiando cellule e tessuti circostanti. Le applicazioni spaziano dunque dalla diagnostica alla terapia. Con questo peptide si possono persino ingegnerizzare i linfociti T, per indirizzarli specificamente sulle cellule tumorali da eliminare.
“Disponiamo di un ventaglio di prodotti interessanti, che stiamo valutando anche in combinazione, per sfruttarne le sinergie” spiega Chiara Bonini. “Abbiamo già scelto i nostri 5 candidati più promettenti per lo sviluppo clinico e stiamo completando gli studi di tossicità e di biodistribuzione. Per questi candidati abbiamo già iniziato il percorso di traslazione clinica, che includerà: in primo luogo, l’adattamento dei protocolli di produzione alle procedure, agli strumenti e agli standard di qualità richiesti per l’uso umano; in secondo luogo, il passaggio dalla produzione in piccola scala a quella in larga scala; e infine la preparazione della documentazione per iniziare un protocollo clinico di fase I (volto a verificare l’assenza di tossicità nei pazienti), che i questo caso sarà anche un primo protocollo clinico negli esseri umani.”
Il percorso prospettato da Chiara Bonini rappresenta una sfida per una realtà accademica, visti i costi di sviluppo clinico richiesti da ogni nuova terapia (solitamente appannaggio di aziende farmaceutiche), soprattutto se si tratta di una terapia avanzata. I ricercatori del programma sono però molto determinati, come testimoniano le parole di Chiara Bonini: “Mi aspetto che questo programma, unico nel suo genere per entità e durata, permetta di mettere a punto molti approcci diversi. Abbiamo scelto 5 prodotti candidati per una prima fase di sviluppo clinico, ma ne abbiamo sviluppati anche altri con un grosso potenziale per sviluppi clinici futuri, e non vogliamo lasciarli nel cassetto. L’idea è di creare una serie di nuovi prototipi medicinali di terapie avanzate, cellulari e geniche, per potenziali applicazioni non solo nelle metastasi epatiche, ma anche in altri tipi di tumore”.
Un lavoro di squadra
Portare avanti un programma così ambizioso, basato su approcci molto diversi e complementari, richiede inevitabilmente un grosso lavoro di squadra, tra professionalità cliniche e di ricerca di base. Al programma infatti partecipano ben 18 gruppi, di cui 5 provengono dalle rispettive unità o divisioni cliniche dell’Ospedale San Raffaele:
- la Divisione di chirurgia epatobiliare, diretta da Luca Aldrighetti;
- l’Unità di radiologia clinica e sperimentale, diretta da Francesco De Cobelli;
- l’Unità di chirurgia del pancreas, parte del Centro di ricerca traslazionale e clinica del pancreas, diretti da Massimo Falconi;
- l’Unità di anatomia patologica, diretta da Maurilio Ponzoni e coordinata, per il programma AIRC “5 per mille”, da Claudio Doglioni;
- l’Unità di oncologia medica, diretta da Michele Reni.
Alle unità cliniche è affidato il compito di reclutare quanti, tra i pazienti dell’Ospedale San Raffaele affetti da metastasi del tumore del colon-retto o del pancreas, vogliono partecipare allo studio clinico osservazionale LiMeT, che sostiene la prima parte del programma di Bonini, sulla caratterizzazione fine del microambiente delle metastasi epatiche (l’acronimo inglese LiMeT sta, in italiano, per “terapie contro le metastasi al fegato”). Il lavoro dei clinici non si ferma tuttavia all’identificazione dei pazienti e alla raccolta dei campioni biologici per la ricerca. Chirurghi, oncologi, radiologi, patologi e data manager seguono infatti la storia clinica, le terapie e il follow-up dei pazienti, fornendo informazioni importanti per l’analisi e l’interpretazione dei dati sperimentali.
Gli altri 13 gruppi provengono da laboratori di ricerca traslazionale e di base, in parte afferenti all’università Vita-Salute San Raffaele, e possono essere raggruppati in base al loro campo di studio principale:
- 4 gruppi, diretti rispettivamente da Paolo Dellabona (Unità di immunologia sperimentale), Maria Pia Protti (Unità di immunologia dei tumori), Giovanni Tonon (Unità di genomica funzionale del cancro) e Renato Ostuni (Unità di genomica del sistema immunitario innato), sono principalmente focalizzati sulla caratterizzazione immunologica e molecolare dei pazienti.
- Altri 4 gruppi, diretti rispettivamente dalla coordinatrice del programma Maria Chiara Bonini (Unità di ematologia sperimentale), Monica Casucci (Unità di immunoterapie innovative), Luigi Naldini (Unità di terapia genica del cancro, Istituto Telethon per la terapia genica del San Raffaele) e Angelo Corti (Unità di biologia e bersagliamento vascolare dei tumori), si occupano soprattutto dell’ingegnerizzazione delle cellule immunitarie e dello sviluppo di vettori lentivirali e altre strategie d’indirizzamento mirato delle citochine immunostimolanti al fegato.
- Infine, 5 gruppi, diretti rispettivamente da Giovanni Sitia (Unità di epatologia sperimentale), Matteo Iannacone (Unità di dinamica delle risposte immunitarie), Chiara Bonini (coordinamento per il programma AIRC “5 per mille”, dell’Unità di attivazione linfocitaria), Lorenzo Piemonti (Istituto di ricerca per il diabete) e Luca Guidotti (Unità di immunopatologia), sono dedicati allo studio in animali di laboratorio della possibilità di mimare il comportamento delle metastasi epatiche umane e la risposta alle nuove terapie sperimentali.
Ogni gruppo ha obiettivi specifici e “mattoncini” da aggiungere allo sviluppo del progetto, la cui “costruzione” è possibile solo a più mani: le mani di oltre 100 partecipanti direttamente coinvolti, ogni giorno, nel programma di Bonini, senza contare i collaboratori di altri laboratori e di servizi, come quelli che si occupano della biobanca istituzionale (Centro risorse biologiche), per citarne solo alcuni.
La presenza di giovani nel programma è notevole. Tanti vantano già brillanti curriculum, testimoniati da riconoscimenti e premi internazionali, e alcuni di questi hanno intrapreso una carriera indipendente, con propri progetti di ricerca e propri finanziamenti: Eliana Ruggiero, Mario Squadrito, Valeria Fumagalli, Stefano Crippa, Alessia Potenza, Arianna Pocaterra, Flavio Curnis, Chiara Balestrieri, Giovanna Giacca, Francesca Ratti sono solo alcuni esempi.
Inoltre, già dall’anno scorso si è costituito un gruppo di lavoro specificamente dedicato alla traslazione clinica dei 5 prodotti terapeutici selezionati nel corso del programma. Il cosiddetto Clinical Translation Working Group è coordinato da Fabio Ciceri, direttore del Comprehensive Cancer Center dell’Ospedale San Raffaele, ed è costituito dai ricercatori che hanno sviluppato i 5 candidati terapeutici, dai responsabili e da rappresentanti delle unità cliniche del consorzio e da vari esperti delle fasi di sviluppo clinico delle terapie avanzate. L’obiettivo del gruppo di lavoro è, da una parte, definire strategie di sviluppo produttivo efficaci e conformi con le richieste degli enti regolatori competenti; e dall’altra, identificare le categorie di pazienti più adatti per le nuove terapie e progettare i primi studi clinici negli esseri umani.
C’è infine un personaggio importantissimo che “tira le fila e ci tiene insieme verso gli obiettivi comuni”: è la program manager Giulia Di Lullo, una figura professionale richiesta dai bandi AIRC “5 per mille” per potenziare la collaborazione e la comunicazione all’interno del programma. Di Lullo si è dimostrata essenziale nel monitorare i tempi previsti per ciascuna attività e per facilitare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di questo programma così interconnesso.