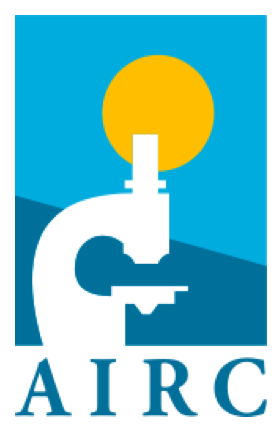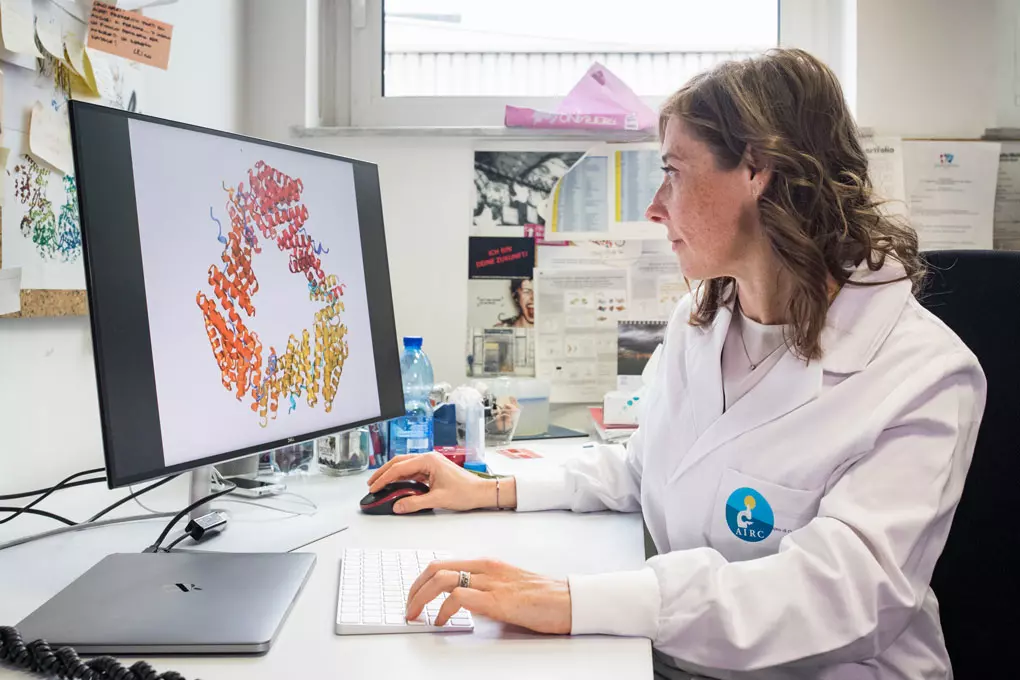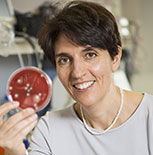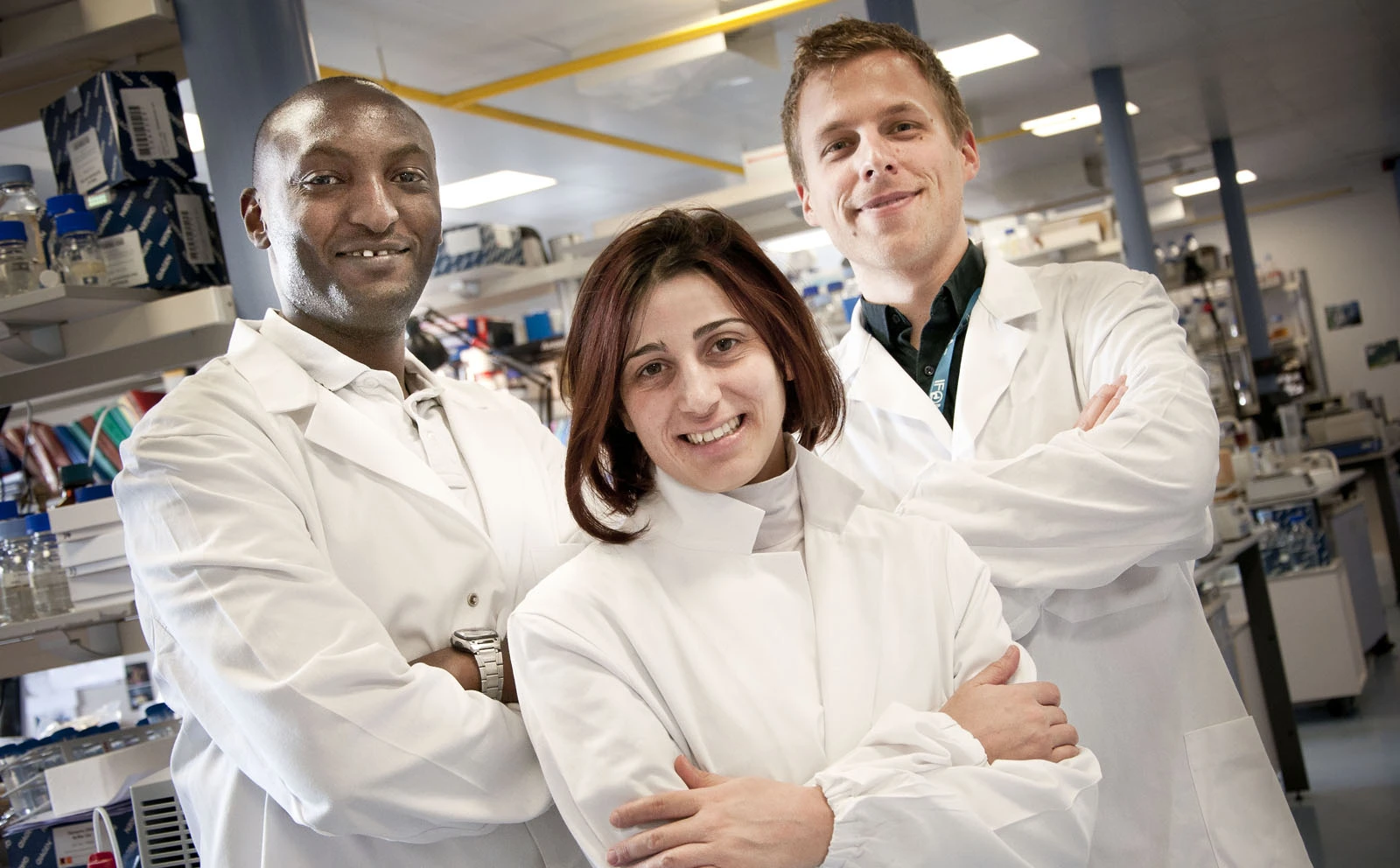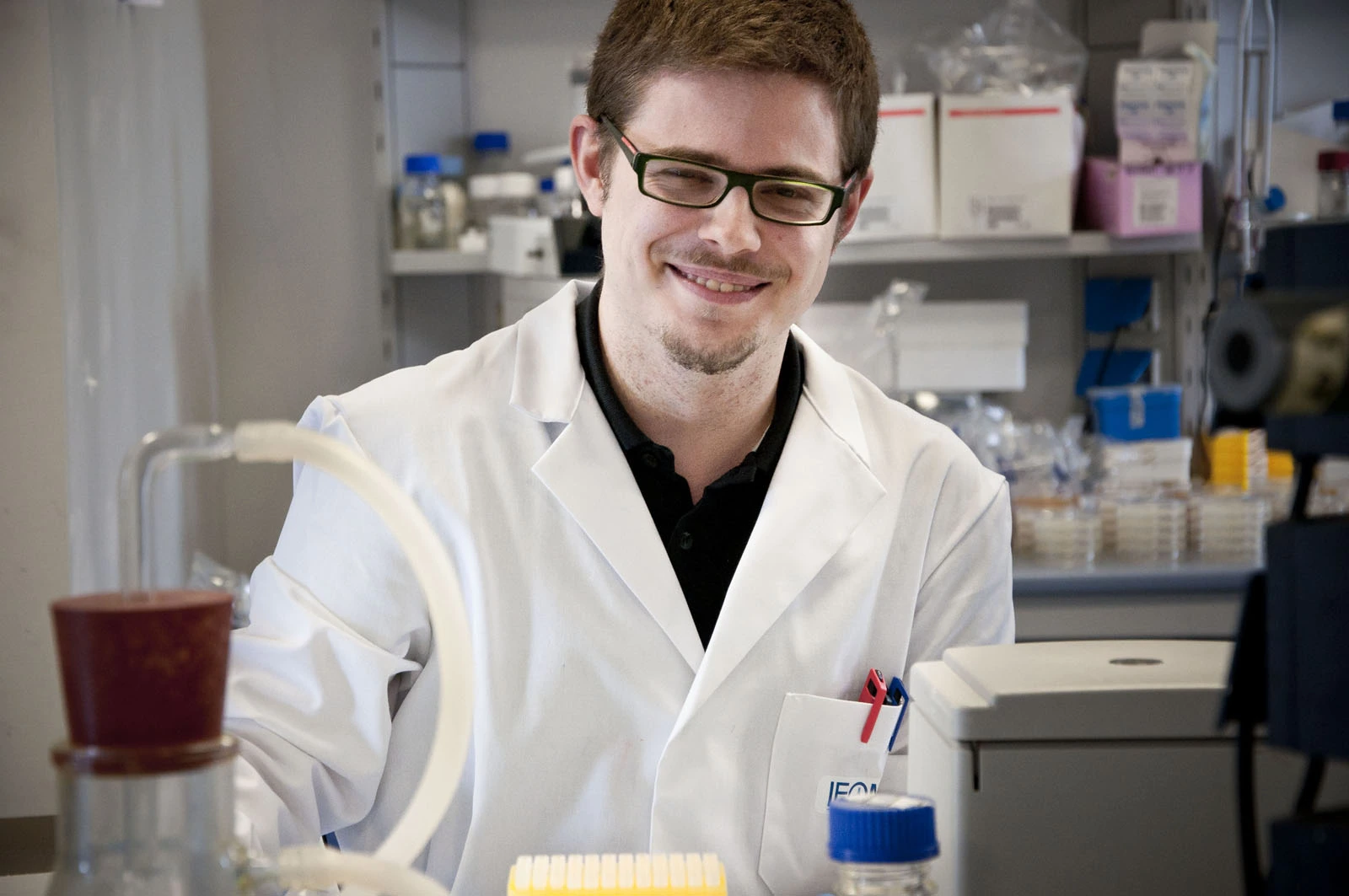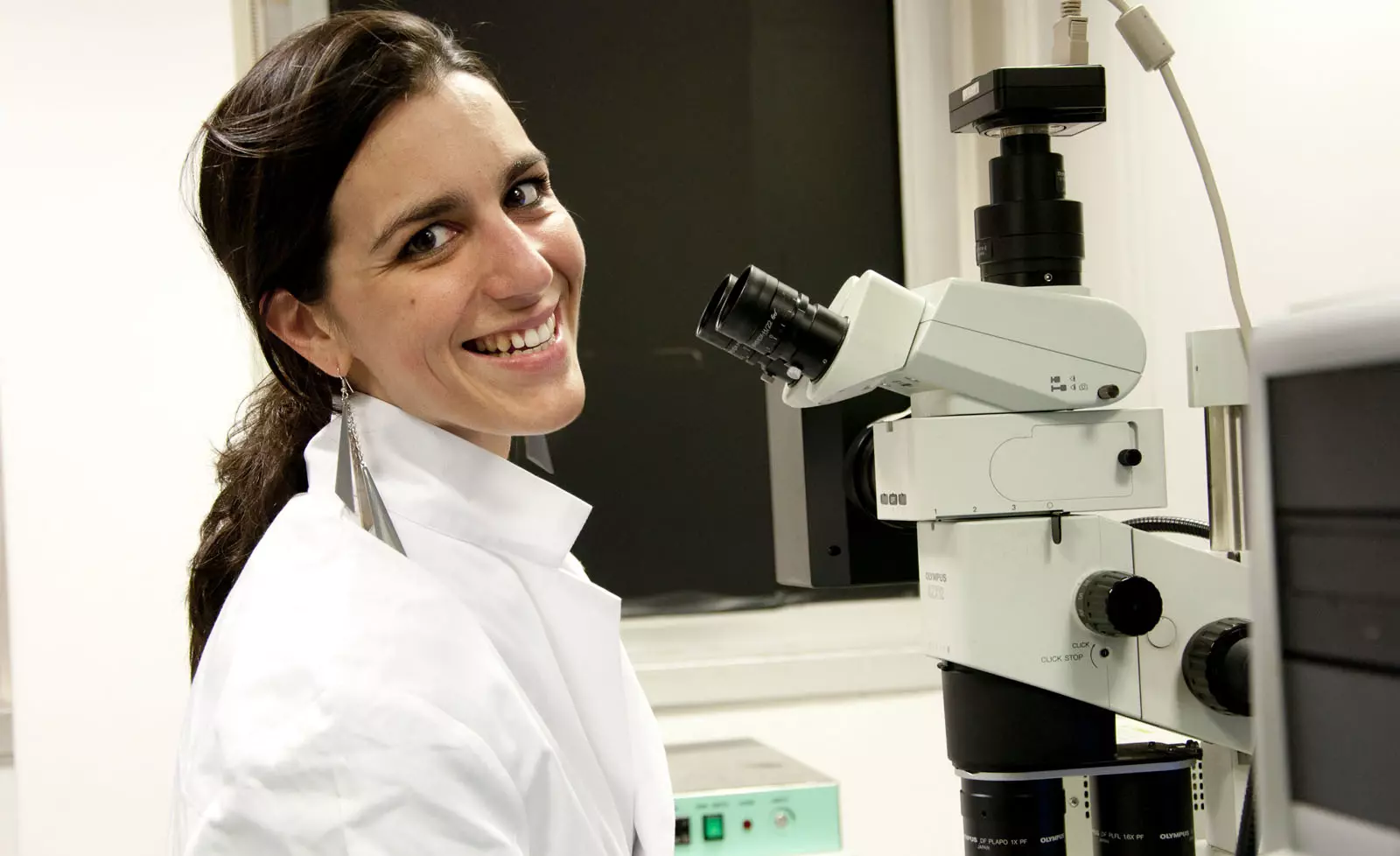Un vaccino terapeutico per migliorare l’immunoterapia contro melanoma e sarcoma metastatici
Il fulcro del programma di ricerca guidato da Maria Rescigno, ricercatrice dell’Humanitas Research Hospital di Rozzano, vicino Milano, è l’immunoterapia e le sue attuali limitazioni. Rescigno dirige un consorzio composto da 8 gruppi di ricerca, distribuiti in tre centri: Humanitas, Università del Piemonte Orientale e Istituto Pascale di Napoli. Il programma è reso possibile grazie al sostegno di AIRC, ottenuto tramite il secondo bando “5 per mille” dedicato allo studio delle metastasi. Nel corso dei 7 anni di durata del programma, Rescigno e il suo gruppo di ricerca si stanno dedicando allo sviluppo di un vaccino terapeutico per combattere alcuni tipi di tumore. “L’immunoterapia ha rivoluzionato la prognosi di alcuni tumori precedentemente considerati incurabili. Tuttavia, c’è ancora una quota di pazienti che non risponde ai trattamenti attuali, basati sui cosiddetti inibitori dei checkpoint immunitari. Questi farmaci rimuovono i blocchi che inibiscono la risposta del sistema immunitario contro il tumore, che diventa così aggredibile. La nostra sfida è quella di attivare la risposta immunitaria in questi pazienti tramite un vaccino terapeutico mirato” spiega Rescigno. Questa strategia potrebbe aumentare notevolmente l’efficacia terapeutica. “Sono molto grata ad AIRC per l’opportunità unica che ci sta dando con questo sostegno eccezionale nel panorama della ricerca italiana e internazionale, sia in termini economici che temporali” dice la ricercatrice.
Gli obiettivi
L’obiettivo principale del programma guidato da Maria Rescigno è valutare, attraverso studi clinici rigorosi, l’efficacia di nuovi vaccini terapeutici somministrati a pazienti affetti da melanoma e sarcoma metastatici, al fine di potenziare la risposta immunitaria. Nel corso dei 7 anni di ricerca, le analisi approfondite a livello molecolare e cellulare permetteranno di decifrare i meccanismi con cui alcuni tumori resistono ai trattamenti immunoterapici e chemioterapici. Inoltre, si cercherà di capire più ampiamente come reagiscono ai vari trattamenti. Queste informazioni, raccolte grazie all’uso di tecnologie d’avanguardia e analisi a diversi livelli (per esempio, sia molecolare sia cellulare), potranno portare all’identificazione di nuove molecole da impiegare in vaccini terapeutici sempre più mirati ed efficaci. “È importante ricordare che questo ambito di ricerca è molto attivo in tutto il mondo, soprattutto in questo momento, ma in Italia siamo all’avanguardia grazie anche al sostegno che AIRC ha sempre dato alla ricerca sull’immunologia dei tumori” spiega Rescigno.
Il percorso
- Un inizio promettente. Grazie ai contributi “5 per mille”, il programma di ricerca si avvale di una base solida, ancora una volta resa possibile dal sostegno di AIRC. Come sottolinea Rescigno, studi pregressi hanno permesso al suo gruppo di individuare nuovi metodi per selezionare peptidi antigenici, molecole essenziali per scatenare una risposta immunitaria mirata contro melanoma e sarcoma. Queste scoperte sono fondamentali per lo sviluppo di vaccini terapeutici specifici, che sono oggetto di valutazione in studi clinici già iniziati nell’ambito del programma. La scelta di concentrarsi su melanoma e sarcoma deriva dalla vasta conoscenza accumulata su queste patologie e dall’esperienza dei gruppi di ricerca, che hanno precedentemente ottenuto risultati promettenti nell’uso di vaccini immunogenici per queste neoplasie.
- Potenziamento delle terapie. Gli inibitori dei checkpoint immunitari (ICP) sono efficaci solo se vi è una presenza adeguata di cellule immunitarie attive contro il tumore. “Se però queste cellule immunitarie non ci sono, o sono troppo scarse, le terapie non possono essere efficaci” spiega Rescigno. In un primo studio clinico si esaminerà l’effetto di questo vaccino in pazienti con melanoma metastatico, seguito da trattamenti con ICP come il nivolumab. In un secondo studio ci si concentrerà invece sul sarcoma, tradizionalmente trattato con chemioterapia, per rafforzare l’approccio standard, incrementando la risposta immunitaria contro il tumore. “Anche in questo secondo caso vogliamo dare forza alla terapia standard creando una base immunitaria più attiva contro il tumore” dice la ricercatrice. “Ci aspettiamo che alcuni pazienti risponderanno e altri no, e il confronto dei dati che otterremo sarà utile a comprendere meglio i meccanismi alla base delle diverse risposte.”
- Monitoraggio intensivo. I partecipanti agli studi clinici saranno sottoposti a un rigoroso monitoraggio del sistema immunitario, il cosiddetto “immuno-monitoring”. Si analizzeranno sia la risposta T (quella dei linfociti T citotossici), sia la produzione di anticorpi da parte dei linfociti B. Saranno inoltre valutate le cellule del sistema immunitario innato, come i macrofagi. Questo monitoraggio includerà anche lo studio del microbiota intestinale, dato il suo ruolo rilevante nell’influenzare l’efficacia della terapia in pazienti trattati con inibitori dei checkpoint immunitari.
- Resilienza e flessibilità. La ricerca richiede di essere costantemente pronti ad adattare le strategie. Per sua stessa natura imprevedibile, la ricerca potrebbe infatti portare a risultati diversi da quelli attesi. Inoltre lo scenario nel quale si opera può cambiare molto rapidamente. “La nostra filosofia prevede di procedere sempre per gradi: iniziamo con il protocollo che abbiamo scritto sulla base delle conoscenze di cui disponiamo ora, e nel frattempo procediamo con il monitoraggio fine delle risposte, rimanendo sempre pronti ad apportare cambiamenti che possano migliorare le strategie terapeutiche” afferma la ricercatrice. Non è un caso che all’interno del programma sia previsto anche una sorta di “piano B” da utilizzare qualora i primi risultati della sperimentazione clinica non siano soddisfacenti. Si tratta dell’utilizzo della cosiddetta immunoterapia adottiva, nella quale per contrastare il tumore si utilizzano cellule del sistema immunitario (linfociti T) appositamente modificate attraverso tecniche di ingegneria genetica.
Perché è importante
Un vaccino terapeutico come quello studiato in questo programma rappresenta un’importante nuova opzione terapeutica per pazienti con melanoma e sarcoma metastatici che non rispondono o rispondono in modo incompleto alle terapie oggi disponibili. Inoltre, i risultati del monitoraggio immunitario aiuteranno i medici a capire meglio quali pazienti potrebbero beneficiare del trattamento, ma forniranno anche informazioni utili per affiancare altre possibili terapie alle combinazioni attuali. I vaccini terapeutici utilizzati nello studio sono stati creati partendo dall’analisi di diversi tipi di cellule tumorali in coltura. Ciò ha permesso di identificare molecole comuni alle diverse forme dello stesso tipo di cancro e di poter quindi arrivare a un vaccino terapeutico “universale”, che tutti i pazienti con un determinato tumore (per esempio il melanoma) possono utilizzare. Su questa falsariga sarà possibile lavorare per creare vaccini terapeutici anche per altri tipi di cancro. “Almeno in linea di principio, la strategia basata sulla vaccinazione potrebbe essere utilizzata in tutti i pazienti per aumentare le loro probabilità di rispondere ai trattamenti successivi” conclude Rescigno.
A che punto siamo
Aprile 2024. Sono stati compiuti progressi significativi nel processo di sviluppo preclinico del vaccino per i pazienti affetti da melanoma; è stata completata una serie di attività fondamentali per introdurre per la prima volta in clinica un tipo di trattamento innovativo (ad esempio sono state definite la solubilità e la stabilità del vaccino). Ora il vaccino da sperimentare è in produzione.
L’entusiasmo dei gruppi di ricerca coinvolti nel programma ha consentito di progredire in tutti gli aspetti preclinici pianificati. Sono stati identificati diversi marcatori in grado di predire la risposta dei pazienti alla terapia immunologica e la loro propensione a sviluppare resistenza ai farmaci. Questi risultati saranno preziosi per anticipare la risposta dei pazienti sottoposti a vaccinazione.
Sul fronte dello sviluppo del vaccino contro il sarcoma, si sta procedendo alla caratterizzazione dei pazienti affetti da sarcoma dei tessuti molli e del loro repertorio antigenico. Il sarcoma dei tessuti molli è una patologia che comprende almeno 50 sottotipi distinti, e quindi rappresenta una malattia complessa, con sfide uniche nel trattamento e nella gestione dei suoi effetti a lungo termine sui pazienti. Tutte le unità coinvolte nel consorzio hanno messo insieme le proprie competenze per questo obiettivo. I sarcomi sono studiati da diverse prospettive, esaminando il microbiota intratumorale, il metaboloma (l’insieme di molecole prodotte dalle reazioni cellulari) e l’ambiente immunologico sia tumorale sia periferico, cercando di correlare tutti questi dati con i diversi sottotipi e con la risposta alla terapia. Diversi peptidi antigenici sono stati identificati e le loro proprietà immunogeniche sono attualmente al vaglio.
Un lavoro di squadra
Il consorzio è composto da 9 unità operative, di cui 4 capitanate da giovani ricercatori, e coinvolge 4 istituti.
Ci sono unità di ricerca di base e traslazionale che sono deputate a valutare l’efficacia del vaccino attraverso un immuno-monitoraggio accurato di diversi aspetti: delle cellule B che producono anticorpi (Marinos Kallikourdis, Istituto Humanitas di Rozzano-Milano); delle cellule T citotossiche che riconoscono e uccidono le cellule tumorali (Enrico Lugli, Humanitas); del microambiente tumorale, in particolare dei macrofagi e neutrofili “corrotti” che aiutano il tumore a crescere (Diletta Di Mitri, Humanitas, e Antonio Sica, Università del Piemonte orientale); e del microbiota, che ha un ruolo fondamentale sull’efficacia della terapia (Maria Rescigno, Humanitas). Il gruppo di ricerca valuterà anche la presenza dei peptidi del vaccino nel sangue dei pazienti trattati e identificherà nuovi peptidi per migliorare la vaccinazione (Marcello Manfredi, Università del Piemonte orientale). Infine, ci saranno due unità cliniche che sperimenteranno nei pazienti l’efficacia e la sicurezza del vaccino (Paolo Zucali e Alexia Bertuzzi, Humanitas, e Paolo Ascierto, Fondazione Pascale di Napoli) e un’unità di ricerca traslazionale per mettere in atto l’eventuale “piano B” (Andrea Biondi, Università Milano Bicocca).
Ecco le impressioni di alcuni partecipanti al consorzio (in ordine alfabetico):
- Ascierto: “Le diverse professionalità ed esperienze si uniscono nell’unico obiettivo di migliorare il beneficio a lungo termine dei pazienti. Rendere il cancro una malattia cronica si può”.
- Di Mitri: “Per me, il programma AIRC ‘5 per mille’ rappresenta la sintesi della ricerca medica, in quanto riesce a combinare spunti personali e spirito di squadra, autonomia e integrazione di competenze, esperienza e innovazione, esplorazione dei meccanismi di base e scoperta traslazionale. È il percorso di crescita di una squadra unita contro il cancro”.
- Kallikourdis: “Il programma ‘5 per mille’ per me sta diventando un’esperienza unica, in quanto ha permesso una convergenza di linee di ricerca di diversi gruppi, con loro interessi scientifici complementari ma distinti, verso un obiettivo comune con reali possibilità di impatto per i pazienti. Sarebbe bello se tutta la scienza fosse così collaborativa”.
- Lugli: “Con questo programma, possiamo mettere decenni di ricerca in laboratorio a servizio dei pazienti per combattere il cancro”.
- Manfredi: “Abbiamo la possibilità di contribuire al miglioramento della cura del cancro attraverso un approccio di squadra, innovativo, multidisciplinare e con i migliori mezzi possibili”.
- Zucali: “Partecipare a un programma che unisce le conoscenze, che scompone e affronta i problemi da più punti di vista con approccio multidisciplinare è un’occasione molto stimolante non solo dal punto di vista formativo, ma anche da quello produttivo!”.